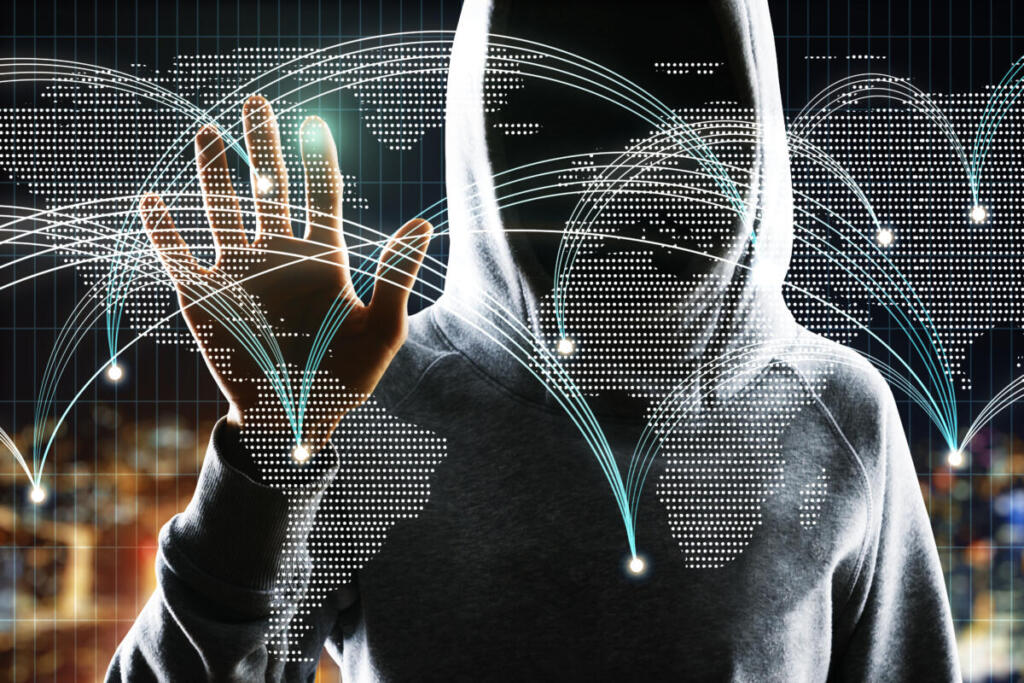Dopo il voto, come è normale, tutti rialzano il tiro. Il principale beneficiato del 20-21 settembre, il Pd, ha iniziato subito le danze. E c’è da capire Zingaretti. Andato al governo per miracolo divino, per il combinato disposto tra le follie grilline e la paura di Salvini, stanco di fare il guardiano, il mediatore, il razionalizzante, il pompiere, il leader della stabilità, rispetto alle perturbazioni dei suoi alleati, e soprattutto, stanco della mancata alleanza giallorossa, da lui sollecitata nelle regioni (anche se in Liguria non ha funzionato, dice lui, per la debolezza del candidato-giornalista), si è affrettato a imporre un cambio di rotta.
Giustificato pure dal fatto che se le cose fossero andate male, avrebbe rischiato la segreteria. E il prossimo anno si vota a Roma e poi, per la Regione Lazio. Tutti appuntamenti a cui i dem adesso guardano con maggiore fiducia.
E quali richieste ha rivolto a Conte e a Di Maio? Il rimpasto, la chiarezza sui progetti del Recovery Fund, lo smantellamento dei decreti sicurezza di Salvini, che allora furono condivisi dai pentastellati e il no alla conferma della Raggi.
La risposta di Di Maio? Nessuna. E la risposta di Conte? Nisba. Niente rimpasto (che vedrebbe, tra l’altro, proposta furba di Renzi, Zingaretti vice-premier), semmai un rilancio. Un rilancio personale, l’ennesimo del premier.
L’uomo, infatti, ha già superato varie maree e tempeste. Conte-1 gialloverde, Conte-2 giallorosso, e ora Conte 3 giallo-fucsia? Proprio no.
Il suo motto, tardo democristiano (“non mi sono mai sentito in bilico, non mi sento ora dopo il voto, inamovibile”), è il viatico galleggiante con cui tutti i capi di governo di transizione, di passaggio, sono diventati permanenti. È l’autobiografia nazionale che al contrario, butta dalla torre, chi entra a Palazzo Chigi lancia in resta, col proposito di fare le rivoluzioni, da Berlusconi a Renzi e a Grillo.
In comune con Zingaretti, Conte ha la gestione del Covid. Hanno saputo interpretare la paura della gente, offrendo sicurezza, prospettive, al posto delle angosce e delle paure vellicate da Salvini e la Meloni.
E i 5Stelle? Anche loro stanno rialzando il tiro, ma non propriamente all’esterno. Dentro le loro mura sempre più anguste. Hanno tradito tutte le loro battaglie identitarie, conservandone soltanto una: il taglio dei parlamentari (esito del referendum 69 a 30), che Di Maio, in vista dei suoi Stati generali, ha venduto come una grande vittoria. Ed è stato costretto a enfatizzare tale risultato, visto che il Movimento a livello territoriale, dati e numeri alla mano, si è ridotto alle stesse percentuali di Fi. Inesorabilmente finiti i bei tempi della Terza Repubblica. E nell’unico luogo dove si è tentato l’esperimento giallorosso elettorale (ripetiamo, la Liguria), esperimento approvato dall’ennesimo sì della piattaforma Rousseau, diventata a comando governista, è stato un flop.
In casa grillina, Di Maio si è di fatto riproposto. Pur nel quadro delle congetture congressuali che ipotizzano una gestione collettiva, lui vuole tornare alla grande, col ruolo di “primus inter pares”; ruolo che Crimi non accetterà mai, né certamente il duo Fico-Di Battista. Quest’ultimo ha ironizzato sulle dichiarazioni di Di Maio. Un segnale emblematico che fa capire la posta in gioco: “Non capisco questo eccesso di esultanza per la più grande sconfitta del M5Stelle”.
Ma il mito della prima ora, sarebbe la salvezza? In politica i tempi, sono diversi e perduto il treno del cambiamento, alla stazione ci arrivano, per regola, altri treni.
(Lo_Speciale)