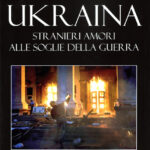In Italia – e direi in buona parte dell’Europa – abbiamo sviluppato una visione quasi romanzata del concetto di sfera di influenza. Ciò dipende anche dall’abilità della politica americana, che nel tempo ha contribuito a rendere questo tema volutamente opaco.
Questa percezione distorta ci porta a commettere due errori fondamentali.
Il primo, che ha generato conseguenze enormi, è credere che l’appartenenza a una sfera di influenza sia una scelta. In realtà, le sfere di influenza si subiscono: raramente si scelgono, e quando accade è per necessità, non per piena volontà. La sovranità, nelle relazioni internazionali, non è solo un dato giuridico-formale, ma anche una questione di rapporti di forza effettivi.
Il secondo errore è considerare noi europei come alleati paritetici degli Stati Uniti.
Pur riconoscendo che tra le grandi potenze gli USA siano la più “benevola” – sono una democrazia, condividiamo un retroterra culturale e, fatto non secondario, hanno garantito la sicurezza dell’Europa – rimane il dato di fatto: apparteniamo all’impero americano. È un impero informale, non codificato, ma pur sempre un impero. A differenza degli imperi storici, con governatori e tributi, l’egemonia statunitense si esercita attraverso meccanismi più sottili ma non meno vincolanti. Il fatto che questo impero sia “benevolo” (gli USA sono tra le potenze la più rispettosa dei propri satelliti) non ne altera la natura strutturale. E in questa struttura noi siamo appunto satelliti, per non dire province.
Accettare questa realtà aiuterebbe a evitare fughe in avanti verso Russia o Cina: inclinazioni personali o interessi particolari contano poco quando si è parte di una sfera di influenza. Ogni deviazione da questo quadro è stata pagata cara, come dimostra la progressiva perdita di influenza nel nostro “estero vicino”.
L’Italia non solo ha perso la guerra, ma assieme ad altre Nazioni europee, ha anche accettato consapevolmente la propria condizione. La presenza militare americana in Europa è stata voluta dai governi europei come garanzia – e come sacrificio preventivo – in caso di attacco nucleare sovietico. Un pegno di sangue.
E se domani l’Italia chiedesse ai 13.000 soldati americani di lasciare il Paese, non ci si dovrebbe sorprendere se quella richiesta venisse ignorata.
Lo stesso vale per il COVID-19: mentre arrivavano “in aiuto” i russi, con due medici e un numeroso seguito della GRU, l’amministrazione Trump rispose dispiegando immediatamente 40.000 militari, portando a 53.000 la presenza USA sul territorio. Il nostro esercito ne conta 83.000: il rapporto parla da sé.
Nella logica di una sfera di influenza, l’egemone – gli Stati Uniti – esercita piena potestà strategica. Questa potestà si estrinseca nel primo esercizio di tale status: la scelta del nemico. È illusorio pensare che l’Europa possa decidere autonomamente su questioni che coinvolgono Russia e Cina. Gli USA forniscono sicurezza e, di conseguenza, stabiliscono le priorità. L’Europa beneficia, ma non guida.
Se questo ragionamento è corretto – e lo è – davvero si può credere che siano gli europei a impedire una pace in Ucraina? La realtà è che Trump, limitato dal Congresso e dalle dinamiche pre–midterm, non può spingersi oltre un cessate il fuoco. La strategia del “disimpegno apparente” risponde a esigenze interne e viene mascherata dal protagonismo britannico, pur essendo definita a Washington.
L’intelligence USA resta attiva, e benché formalmente finanziate dagli europei, le armi che arrivano in Ucraina sono statunitensi. I russi lo sanno perfettamente, anche se accusano l’UE. Nel gioco delle ombre Mosca mantiene aperto uno spiraglio di dialogo con Washington, ma solo per ridisegnare l’architettura di sicurezza europea. Un cessate il fuoco è inviso a Mosca, perché viene letto come un’applicazione del principio di sequenziamento strategico. Una pausa prima di riprendere la guerra.
Il paradosso è che l’Europa, accettando il proprio ruolo di provincia dell’Impero, si è convinta che il mondo sia fatto soltanto di economia. Ha abbracciato l’illusione della “fine della storia” di Fukuyama, dimenticando che l’economia è solo uno strumento della potenza.
Oggi però gli Stati Uniti chiedono all’Europa di tornare nella storia, di contribuire alla deterrenza non solo verso la Russia ma anche verso la Cina. È una richiesta resa inevitabile dalla natura globale della sfida.
Questo richiamo, persino quando espresso in modi bruschi, sembra non trovare interlocutori. In molti continuano a immaginare che, una volta finita la guerra in Ucraina, si tornerà a bere vodka e mangiare spaghetti, nella logica del “volemosebene”.
Sebbene molti vertici politici e militari prevedano un’invasione russa nei prossimi anni, francamente non ritengo di allinearmi a questa visione, anche perché non mi sembra che alle grida di allarme seguano azioni concrete per fronteggiare questa eventualità. Ma non si ritornerà indietro, la minaccia vera sarà una guerra ibrida permanente
La Russia conosce bene la logica delle sfere di influenza e, da ex superpotenza, sa giocare partite molto lunghe. Al di là degli affari possibili, guarderà a un’Europa uscita dalla storia, divisa, insofferente, e quindi vulnerabile. La Russia farà ampio uso delle armi della guerra ibrida autonoma: finanziamenti occulti per destabilizzare, cyberattacchi, operazioni di influenza. Sarà un conflitto non cinetico permanente di bassa intensità, combattuto su più fronti, dove distinguere tra interno ed esterno, pubblico e privato, pace e guerra diventerà sempre più difficile.
La conseguenza del conflitto ucraino sarà probabilmente un periodo di pace ibrida, non guerra convenzionale, ma nemmeno una pace reale. E anche se la situazione si normalizzasse, presto o tardi dovremo prendere atto che se si è fuori dalla storia, inevitabilmente la si subisce. La scelta quindi non è tra essere potenza o essere neutrali, ma tra essere soggetti attivi o oggetti della geopolitica altrui.