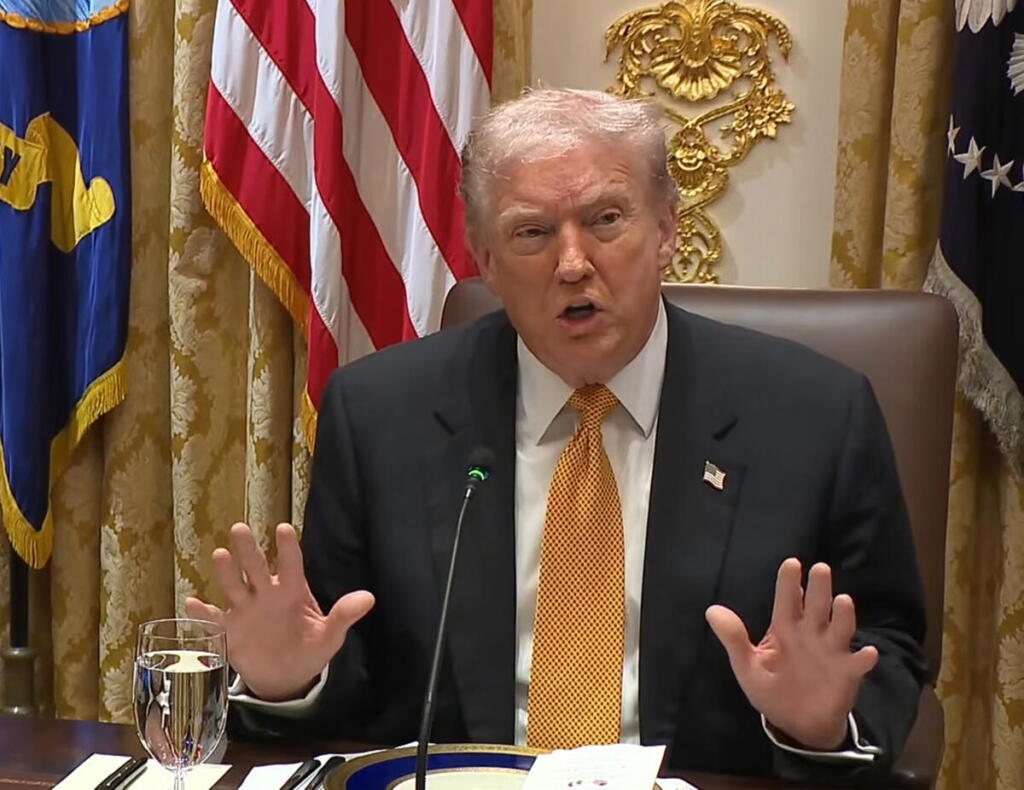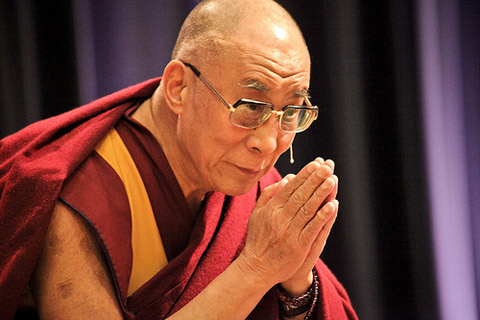Il punto non è univoco, direbbe Carl Schmitt. È una interferenza biunivoca di punti che si contrappongono sull’asse verticale morale e su quello orizzontale legale. Non si tratta di stabilire se lo sfratto di uno storico centro sociale come Leoncavallo dopo cinquant’anni di traversie politico-giudiziarie sia oggi cosa giusta o ingiusta, ma di stabilire se questo non sia per un centro storicamente culturale un imbratto legittimo della giustizia sociale di un intero Paese.
“Non appartengo a nessuna razza eccetto quella che mi è stata imposta. Non ho una terza eccetto quella cui sono obbligato ad appartenere. Non ho tradizioni. Sono libero. Appartengo solo al futuro”.
Questa massima di Richard Wright, presa a motto sul sito leoncavallo.org dal libro Spagna pagana del 1957, dovrebbe essere l’attuale epitaffio di un’era quale è stata Leoncavallo.
La frase del tastierista dei Pink Floyd è di per sé una triplice eccezione della tradizione, quella storico-culturale europea ed occidentale. E come sappiamo, laddove scaturisce l’eccezione germoglia una rivoluzione.
L’edificio che la storia delle ultime Avanguardie postbelliche ha consegnato a noi più come prodotto culturale della società milanese che come proprietà patrimoniale della famiglia Cabassi, si è avvalso in tutto questo tempo della “licenza poetica” dell’Arte come salvaguardia giuridica della sua bona fides. Come a dire, Leoncavallo non si può demolire perché è protetto dal suo riconoscimento implicito di patrimonio artistico culturale.
L’occupazione abusiva dell’intera area di Leoncavallo da parte dei gruppi che nel 1975 si erano radunati contro “i padroni della città”, come essi stessi chiamavano le elites dei conservatori, per far rivalere una loro carta dei diritti che erano evidentemente trascurati agli occhi dei cittadini della Prima Repubblica, è fenomeno non lecito ma legittimabile. E lo è in quella dualità politica del potere di cui parla Agamben in Homo Sacer, ossia vita legale e legge ideale.
L’occupazione era lecita per il suo senso di rivoluzione che esprimeva, ma non per forza ogni atto che nasce come segno rivoluzionario è automaticamente legittimato dalla storia per consuetudine, specialmente se si tratta di un abuso di proprietà che continua a non essere pacificato dalla stessa famiglia proprietaria. La famiglia Cabassi avrebbe il potere legale di rivendicare a suo uso e possesso esclusivo la proprietà occupata di Leoncavallo, ma se volesse, avrebbe anche il diritto morale di concedere il privilegio alla società occupante, di manutenere la struttura nel suo senso di patrimonio artistico e culturale che è divenuto durante gli anni.
Ma non dovremo meravigliarci se oggi ciò non accade. Ogni patrimonio materiale infatti come quello della famiglia Cabassi, nella storia del diritto si è sempre scontrato col suo possesso naturale da parte di altri agenti che imponendosi con la forza, (vuoi per necessità o per atto appunto politico), accedono naturalmente, e non legalmente, all’oggetto di proprietà altrui.
Da un lato questo scontro tra legge e politica ha sancito dei precedenti in cui l’uso del bene di proprietà altrui veniva concesso sotto l’investitura legittimante di arte pubblica, cioè politica, divenendo così oggetto protetto da rivendicazioni private. Dall’altro lato invece abbiamo anche il precedente storico per cui quello stesso abuso di possesso su proprietà altrui non era tale nella sua natura sociale e politica da giustificarsi come Arte pubblica. In tal caso il bene abusato continuava ad essere rivendicato come bene privato e non veniva riconosciuto come bene culturale pubblico.
Tra i molteplici esempi offerti dalla storia quello più celebre ma rappresentativo è proprio la trasformazione della Bastiglia e dell’intero palazzo delle Tuileries divenuti poi nuovi centri sociali di identità nazionale per iniziativa popolare di tipo militare.
Ogni rivoluzione intellettuale genera il compromesso sociale sotto l’egida politica della sua azione che sebbene illegale, è giustificabile sul lato morale del suo valore pubblico di Arte. E quello di Leoncavallo è stato proprio un atto di rivoluzione morale dell’arte politica, perché l’occupazione è nata esse stessa come atto d’arte, eversivo o no che fosse, nell’opinione di quel gruppo originario.
Ma al di là della loro opinione, era ed è davvero Arte la loro rivoluzione?
È qui che il critico d’arte deve farsi giudice di questa azione pubblica dell’arte, e il giudice deve farsi critico di questa operazione contro l’arte, se si vuole evitare che lo sfratto legale diventi un ennesimo imbratto illegale identitario, ovvero gratuita rimozione autarchica da parte dello Stato di un pezzo concepito come di storia del Paese. La giusta equazione, la sola che deriverebbe da questa inversione complementare di ruoli della cosiddetta “critica giusta”, è proprio quella di far corrispondere in legge il diritto tra proprietà legale e patrimonio culturale, attraverso un riconoscimento che non si nutra solo di criteri meccanicamente normativi, ma anche cognitivi e dunque naturalmente intellettivi.
Per rispondere allora alla domanda se si tratti veramente di arte tale che possa giustificare l’abuso legale, si adotterà una distinzione netta tra il valore dell’arte contemporanea ed arte estemporanea. Forse lo era lì sul momento, una forte espressione di rivoluzione, ma oggi diremmo, anche per il tipo di decorso culturale che ha visto questi cinquant’anni provenire da Leoncavallo, che si tratti di un processo artistico incompiuto e replicato più con ostinazione che con cognizione. Quella di Leoncavallo rappresenta più la confusione di un’arte che resta estemporanea, e che ci è muta oggi, che non ci parla con la stessa intensità di un dipinto di Mondrian che ci è ancora contemporaneo . Quella insistente sull’edificio di proprietà Cabassi non è arte contemporanea, ma estemporanea. Sarebbe necessario forse allora prendere le distanze dal pleonasmo della sospensione del giudizio di questa “situazione” (nel senso veramente epistemologico), espressa da Vittorio Sgarbi in una delle pagine del suo catalogo pubblicato da Skira nel 2006 “I graffiti del Leoncavallo” e curato insieme ad Alessandro Riva e Davide Atomo Tinelli. Le pagine sono state riprese recentemente da un articolo firmato Sgarbi su Artuu Magazine proprio riguardo al caso dello sfratto di Leoncavallo.
Se la contemporaneità delle pitture murali di via Watteau (su cui si affaccia il centro sociale) è credente dello stesso Dio di Basquiat o di Rimbaud o di Kiefer o di Yukinori Yakagi, o persino di Caravaggio, non significa eguagliare il carattere dell’Arte alla lingua della Società. Tocca al critico giudicare cosa sia Arte e cosa no, affinché il suo modello abbia veramente una ricaduta paradigmatica e paideutica nel corpo della polis, e diventi quindi questione politica, cioè di pubblica amministrazione per il bene comune.
Ma non tutte le opere compiute da un atto di rivoluzione, e dunque da una eccezione legale, sono da giudicare Arte, ma anche solamente “realtà tecniche, della società” se vogliamo mantenere la stessa distinzione per la quale è nato il concetto di Arte con l’uomo moderno. Techne e Ars si misurano nella stessa relazione in cui operano Società e Giustizia. Tocca al critico giudicare quale opera sia giusto modello per il Bene comune, e al giudice quale azione sia l’ingiusto modello per la Pace comune.
L’arte di Leoncavallo poteva essere da modello all’identità del nostro Paese finché non generasse il paradigma di un imbratto concatenato dalla ostinazione formale al suo sfratto.