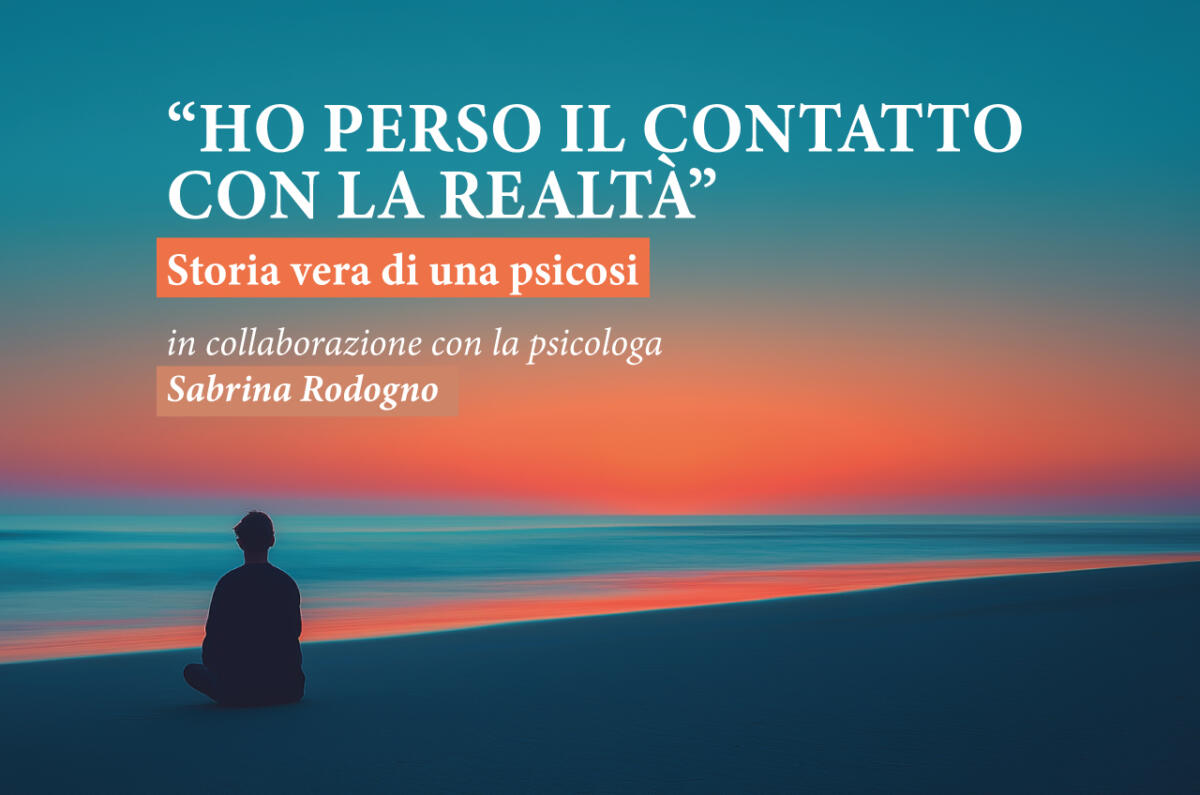Marco ha quasi quarantotto anni e vive a Roma. Ci sono parti della sua infanzia che non ricorda. Non perché non voglia, ma perché non può. La malattia gli ha cancellato dei frammenti, come se qualcuno avesse passato una spugna su alcune stanze della sua memoria.
Da bambino era molto timido, chiuso. Non nel senso romantico del termine: semplicemente, non sapeva come stare al mondo. Già allora era seguito da una psicologa infantile. Nel 1992 ha avuto la prima crisi epilettica. Nel 1997 la seconda. Nel 2008 è arrivato il primo ricovero psichiatrico volontario. Poi un altro, nel 2010.
Quando gli chiedo quale sia la sua diagnosi, risponde senza enfasi: epilettico, con sintomi di psicosi, paranoie, ansia, panico, depressione, disturbo bipolare. Lo dice come si elenca una serie di dati anagrafici. Non per provocazione. Per abitudine.
Conosce bene lo stigma. Non quello esplicito, ma quello che si insinua nelle pieghe delle relazioni. Quello che non viene dichiarato, ma si avverte. Nelle pause, negli sguardi, nelle distanze che si creano senza essere nominate.
Nei contesti che frequenta abitualmente — quelli legati alla salute mentale, alla disabilità, alla musica — si sente al sicuro. Lì c’è familiarità. Lì non deve spiegare nulla. Ma fuori da quei perimetri, qualcosa cambia. Torna una forma di allerta. La sensazione di essere osservato. Il timore di essere frainteso, ridicolizzato, ridotto a una categoria.
Lo stigma non è solo un fatto sociale. È anche un processo interno. Dopo un certo numero di esperienze, si impara ad aspettarsi il rifiuto. Si anticipa. Ci si prepara.
Gli chiedo cosa gli è rimasto più impresso dei ricoveri. Non parla di paura o di dolore. Dice: “La noia sul letto”.
Lo dice senza cercare effetti. Ma quella frase resta.
Oggi, però, la sua vita è tutt’altro che immobile. La definisce “iperattiva”. Fa radio. Suona il pianoforte. Accompagna un coro. Partecipa alle attività del Centro di Salute Mentale. Il sabato suona in una band. La domenica va al cinema, ai concerti, scrive poesie, canta, segue il calcio, lavora al suo terzo libro. Cura anche due rubriche sulla salute mentale.
Il cambiamento è iniziato quando ha scoperto la musica. Poi, più avanti, quando è entrato in modo stabile nei circuiti della salute mentale e della disabilità. Lì ha trovato spazi in cui non era più solo “un paziente”, ma una persona tra le altre.
Quando gli chiedo cosa succede nel momento in cui arriva il panico, risponde in modo molto concreto: lo senti nel corpo. Perdi sicurezza. Perdi orientamento.
Ha una strategia per gestirlo?
Prende l’ansiolitico.
Non c’è retorica in questa risposta. C’è solo una pratica quotidiana.
Alla parola “paranoia” associa una cosa precisa: la paura che gli altri lo prendano in giro.
La depressione, per lui, non ha un’unica forma. È tristezza, ma anche assenza. Tristezza perché ci si sente inadeguati. Assenza perché ci si sente soli.
Non ha mai attraversato fasi in cui si sentiva invincibile. Non si è mai percepito onnipotente. Si definisce fragile, sensibile. Lo dice senza vittimismo e senza orgoglio. È una constatazione.
Gli chiedo cosa lo abbia aiutato di più, nei momenti peggiori. Risponde senza esitazione: l’amicizia.
Per lui, le relazioni non sono un contorno. Sono una struttura.
Marco non è un simbolo, né un esempio edificante. Non è nemmeno un “caso”. È una persona che ha dovuto imparare, nel tempo, a costruire una vita compatibile con la propria vulnerabilità, senza farne un’identità totale.
Il consiglio che dà è semplice: trovare uno spazio, anche piccolo, per ciò che tiene in piedi. Una passione. Un’attività. Qualcosa che non ruoti intorno alla diagnosi.
Non è una formula. È una necessità.
Il punto, forse, è questo: la salute mentale non ha bisogno di narrazioni eroiche. Ha bisogno di contesti abitabili. Di luoghi in cui la complessità non venga subito semplificata. Di relazioni in cui non sia necessario giustificarsi.
Marco non chiede di essere compreso. Chiede di non essere ridotto.