Negli ultimi anni il nome di Palantir è entrato con sempre maggiore insistenza nel dibattito pubblico. L’azienda statunitense, cresciuta grazie ai contratti con agenzie governative e grandi corporation, si è affermata come uno dei principali attori nel campo dell’analisi avanzata dei dati. Ufficialmente, la sua missione consiste nel fornire strumenti utili all’intelligence e alla sicurezza nazionale; tuttavia, l’estensione e la potenza delle tecnologie sviluppate sollevano interrogativi che superano di molto il semplice contrasto al terrorismo o alla criminalità organizzata. Non si tratta più di un semplice supporto all’intelligence, ma di un’infrastruttura che può orientare l’azione istituzionale in modi difficilmente verificabili.
Le piattaforme di Palantir consentono di tracciare profili estremamente dettagliati di tutti i cittadini, attribuendo loro un indice di “rischiosità” basato su modelli algoritmici predittivi. Il termine preciso “indice” può non essere usato da Palantir, ma le funzionalità di scoring/prioritization esistono nei contratti/descrizioni. Se questi strumenti vengono impiegati per individuare vere minacce — cellule terroristiche, reti criminali, attività sospette — il loro valore appare indiscutibile. Ma che cosa accadrebbe se gli stessi algoritmi iniziassero a classificare come pericoloso un comportamento innocuo, un orientamento politico, o persino una forma di dissenso critico? È un punto cruciale: gli algoritmi non sono neutrali, ma incorporano scelte, priorità e visioni del mondo dei loro creatori e committenti. La governancedell’algoritmo è, di fatto, governance della società.
Il rischio più grande non è l’abuso intenzionale, ma la normalizzazione progressiva di un sistema in cui la valutazione algoritmica diventa criterio implicito di merito, affidabilità, accesso ai servizi, mobilità sociale o libertà individuale. Non sono solo ipotesi. Ci sono già stati precedenti di errori o uso coercitivo dei dati. .
Pur lontani dal modello cinese, ne condividiamo la logica di fondo: classificare la popolazione, trasformare comportamenti e relazioni in metadati valutativi, prevedere il futuro delle persone in base ai loro pattern. In entrambi i casi il cittadino verrebbe valutato non solo per le sue azioni, ma anche per ciò che pensa o potrebbe pensare. Si configurerebbe così una nuova forma di potere: un’algocrazia, un governo invisibile retto da algoritmi che decidono chi è affidabile e chi merita sorveglianza.
Questo rischio non è affatto astratto. In una società sempre più dipendente dai dati, governata da piattaforme digitali e modelli automatizzati, la linea che separa sicurezza collettiva e controllo sociale diventa sempre più fragile.
La sfida, dunque, non è puramente tecnologica, ma anche politica e culturale e la soluzione non può essere delegata agli algoritmi e bisognerà vigilare perché lo sviluppo tecnologico non sfoci in nuove forme di dominio.






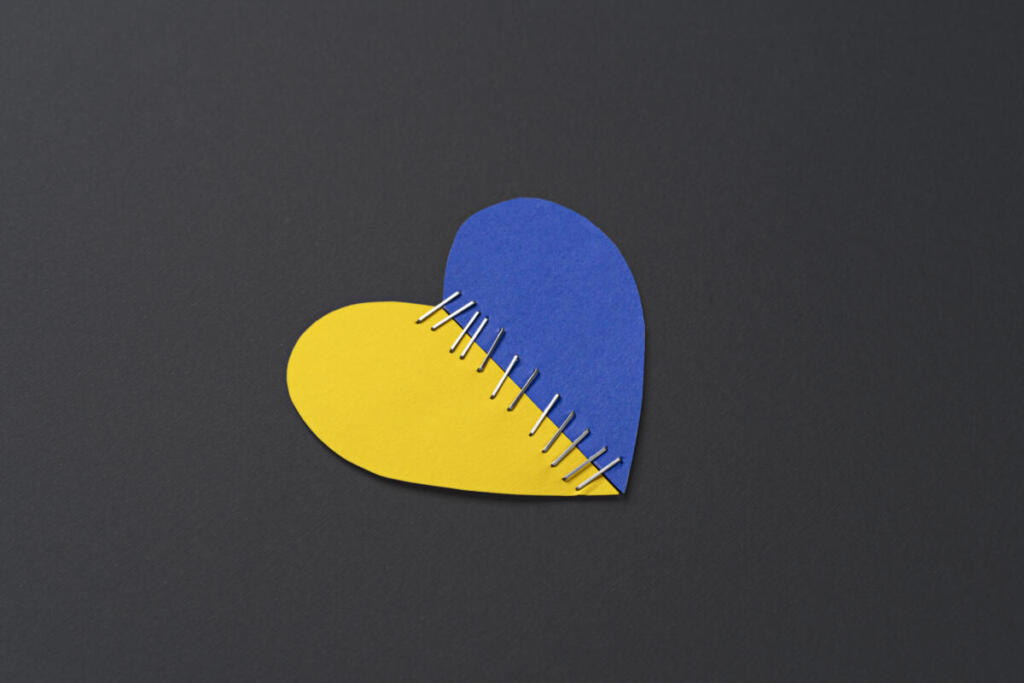


affidarsi alle “macchine o peggio ai computer” porterà alla distruzione sociale. se il “controllo” proprietà di un sistema dittatoriale allora ci saranno problemi e non solo etici. Forse la famiglia nel bosco ha anticipato i tempi con grande preveggenza.