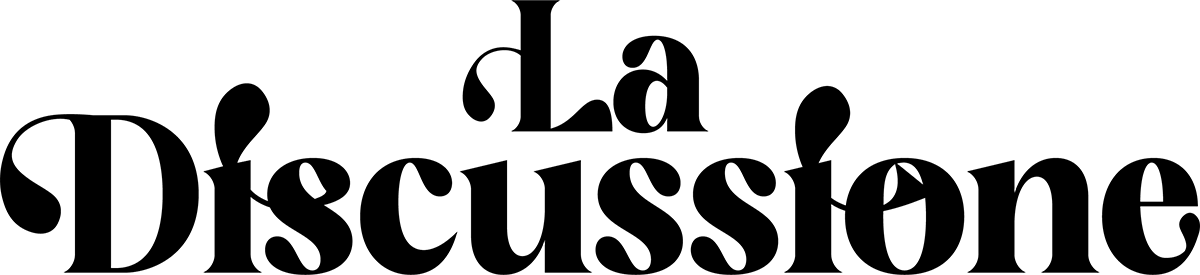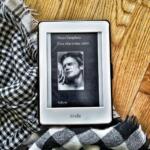Beatrice Venezi è nell’occhio del ciclone dopo essere stata nominata direttrice musicale del teatro “La Fenice” di Venezia, uno dei palcoscenici lirici più prestigiosi al mondo. La nomina, promossa dal sovrintendente Nicola Colabianchi, ha fatto scoppiare il caos. Infatti, maestranze ed esponenti politici considerano la Venezi poco preparata per l’incarico e soprattutto appoggiata politicamente.
Tuttavia, le nomine di questo tipo hanno spesso implicazioni politiche e quasi sempre vengono accettate al di là degli orientamenti. Stavolta, però, Colabianchi pur muovendosi nel rispetto del regolamento, avrebbe ignorato la tradizionale prassi per cui l’orchestra dovrebbe essere consultata e ascoltata prima di avanzare una tale nomina. Infatti, il direttore musicale è una figura che, oltre a essere sempre a contatto con i musicisti, si occupa anche della programmazione teatrale assieme al sovrintendente e definisce l’indirizzo complessivo della stagione lirica e sinfonica. Non essere in sintonia con gli orchestrali significa rischiare di inficiare la reputazione intoccabile dell’istituzione teatrale. Si capisce dunque l’importanza di una simile figura, che oltre a dirigere l’orchestra influenza l’intero ambiente artistico.
Le origini
Per capire meglio le radici della querelle vale la pena ripercorrere le origini e le funziona di questa figura così centrale. Secondo il dizionario italiano, il direttore d’orchestra è semplicemente “chi dirige le esecuzioni musicali di un insieme di strumentisti”. Sebbene la necessità di una guida ritmica ed espressiva fosse riconosciuta fin dall’antichità, l’uso di una gestualità manuale convenzionale risale al Medioevo, al praecentor, cioè al direttore di coro del canto gregoriano, il quale attraverso movimenti della mano indicava l’andamento della melodia. Solo nell’800 si impone la figura come la conosciamo oggi, con la famigerata bacchetta impiantata nella mano destra per tenere il ritmo.
Il ruolo
A livello teorico e metodologico, la figura del direttore d’orchestra ha influenzato nei decenni numerosi studi di carattere economico e manageriale, rivelando così la sua importanza al di là dello stretto ambito musicale. Molti studiosi sono stati ispirati dalla figura del direttore d’orchestra e l’hanno utilizzata come esempio di leadership. Tra questi, L.R. Sayles (1964) paragona il direttore di un’orchestra sinfonica al responsabile di produzione che cerca di fare lavorare in armonia le sezioni dell’impianto produttivo attraverso il coordinamento, il controllo della sequenzialità e dei tempi delle attività, e modera l’energia di tutti per permettere a ciascun partecipante di superare le difficoltà personali.
La rilevanza del concetto di leader, inteso come figura cardine nei processi organizzativi e gestionali, fa sì che il direttore d’orchestra debba sempre essere capace di coordinare e ispirare, nonché motivare verso il miglioramento globale del gruppo che gestisce. Come ha affermato il maestro internazionale Alekseev: “Se un professore può sempre insegnare qualcosa agli studenti grazie al divario nelle competenze, un direttore d’orchestra si trova a gestire un gruppo di colleghi. È dunque importante che il direttore d’orchestra sia totalmente immerso nella musica, che tutti traggano piacere dal processo creativo e dal fatto di lavorare assieme”.
La dimensione politica
Il direttore d’orchestra non esercita un potere politico diretto, ma opera in un contesto politico e istituzionale in cui le sue scelte artistiche possono avere valore simbolico, sociale e culturale, quindi anche politico nel senso più ampio del termine, soprattutto nei teatri pubblici o finanziati da enti statali o comunali.
Più nello specifico, il direttore artistico di un teatro definisce la linea artistica e culturale del teatro (programmazione di spettacoli, festival, stagioni teatrali, scelte di registi, compagnie, artisti); cura la coerenza del progetto culturale con l’identità del teatro; si coordina con la direzione amministrativa e tecnica; rappresenta il teatro in ambito culturale, accademico e mediatico.
Pur non essendo, dunque, un politico, le sue scelte influenzano il dibattito culturale e sociale, attraverso ad esempio la scelta di testi impegnati, contemporanei o di denuncia oppure qualora rappresenti un orientamento culturale che può essere più o meno in linea con la visione dell’Ente che finanzia il teatro (Comune, Regione, Ministero, Fondazioni). La sua stessa nomina può essere su base fiduciaria o politica, soprattutto nei teatri pubblici o stabili. Può essere, cioè, espressione del consiglio d’amministrazione, spesso composto da rappresentanti istituzionali. Infine, partecipa al dialogo con le istituzioni per ottenere fondi, patrocini o inserire il teatro in progetti territoriali.