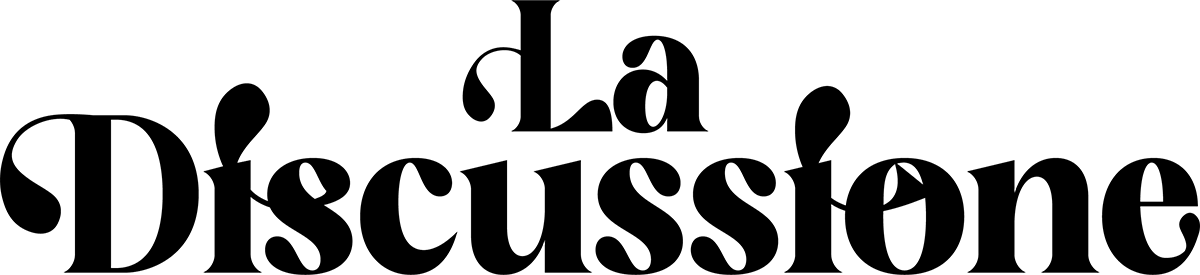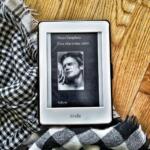Nei giorni in cui i leader del mondo si riuniscono a Belém per la Cop30 l’Onu torna a ricordare che le guerre del nostro tempo non lasciano solo città distrutte e popoli in fuga. Lasciano fiumi contaminati, foreste incendiate, terreni che non torneranno più coltivabili. Sono effetti collaterali di cui si parla poco e su cui ancora non esiste una tutela penale chiara. Negli ultimi mesi diversi giuristi hanno rilanciato l’urgenza di riconoscere una responsabilità che non riguarda soltanto le vittime dirette, ma i danni inflitti al Pianeta. Tra loro anche Charles C. Jalloh, membro della Commissione di diritto internazionale, che sostiene l’esigenza di inserire l’ecocidio tra i crimini più gravi del sistema penale internazionale. Nella lettura di Jalloh la natura non è un semplice campo di operazioni. È un soggetto che può essere ferito e annientato come una comunità umana.
Che questa consapevolezza sia ormai inevitabile lo dimostrano i dati dei conflitti attuali. A Gaza sono stati distrutti la quasi totalità degli alberi, dei parchi e degli arbusti, insieme a gran parte dei terreni agricoli. L’acqua è contaminata da residui di esplosivi e da liquami. Le macerie accumulate superano le decine di milioni di tonnellate. In Ucraina la distruzione della diga di Kakhovka ha allagato centinaia di chilometri quadrati e liberato sostanze tossiche depositate nei sedimenti del Dnipro. La distruzione degli ecosistemi non riguarda solo i luoghi, ma anche gli animali che li abitano. Le cronache da Gaza e dall’Ucraina, con veterinari uccisi e allevamenti rasi al suolo, ricordano che la guerra travolge ogni vivente.
In molte aree del Sahel e negli altopiani dell’Afghanistan la scarsità d’acqua si intreccia con gli effetti di anni di guerre e produce migrazioni ambientali che diventano un nuovo fattore di instabilità. La direttrice del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha parlato di circolo vizioso. E non serve trovarsi in un teatro bellico per vedere violazioni profonde del rapporto con il vivente. Come mostrano le recenti denunce dalla scena marocchina sulla strage dei cani randagi, la tutela degli animali non è ancora patrimonio universale e richiede strumenti più chiari e più forti. Quello che va assolutamente ricordato è che l’ambiente, una volta devastato, diventa esso stesso un generatore di conflitti. Nel caso particolare della guerra, al termine resta un territorio che non può più essere abitato.
Dal diritto internazionale al diritto italiano
La questione è globale, ma interroga i singoli sistemi giuridici nazionali. L’Italia possiede una normativa sul disastro ambientale che rappresenta uno dei tentativi più avanzati in Europa di definire la responsabilità per danni gravi agli ecosistemi. L’articolo 452 quater del codice penale punisce chi provoca un alterazione irreversibile di un ecosistema oppure un danno il cui ripristino richiede interventi eccezionali. Si specifica che la condotta deve essere abusiva e, sfortunatamente, l’imprecisione del termine crea non pochi problemi interpretativi. L’evento può assumere forme diverse. Può essere la compromissione del suolo, delle acque, dell’aria. Può essere la distruzione di un ecosistema naturale. Può essere un pericolo grave per la incolumità pubblica quando il fatto coinvolge una popolazione estesa. È una norma importante, ma concepita per contesti di pace. Non riesce sempre a descrivere la devastazione prodotta da un esercito, le operazioni belliche che annientano un territorio nel giro di pochi giorni.
Per questo l’Independent Expert Panel ha proposto di aggiungere allo Statuto della Corte penale internazionale un articolo otto ter, che definisce l’ecocidio come la distruzione grave e su vasta scala di ecosistemi con effetti duraturi, compiuta con la consapevolezza che tale distruzione avverrà. È una svolta concettuale. La tutela dell’ambiente non deriva più dal pericolo per l’uomo. L’ambiente viene riconosciuto come soggetto autonomo della protezione penale. Ciononostante è un passaggio che solleva questioni complesse. Che cosa significa danno grave? Come stabilire la durata? Come accertare l’effettiva consapevolezza della condotta? Ma è un passo verso un diritto internazionale capace di misurarsi con la forma contemporanea della guerra.
Una prospettiva storico culturale italiana
Questa discussione, che riguarda la sovranità degli Stati e la definizione dei crimini più gravi, si interseca con un tratto profondo della cultura italiana. L’Italia è uno dei pochi Paesi che già nel testo originario della Costituzione ha riconosciuto il valore del paesaggio. L’articolo nove stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Per la fine degli Anni Quaranta era un principio visionario. Non esisteva ancora la nozione moderna di ecosistema. Non esisteva un diritto ambientale strutturato. Eppure il paesaggio veniva collocato tra i fondamenti della Repubblica come bene primario, non inferiore alla cultura e alla ricerca. È un anticipo concettuale di ciò che oggi chiamiamo tutela ecologica.
Questa intuizione è stata confermata e aggiornata di recente. Con la legge costituzionale numero uno dell’undici febbraio 2022 il Parlamento ha modificato proprio l’articolo nove e l’articolo quarantuno della Carta. Nel testo dei principi fondamentali è stata inserita in modo esplicito la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, con un richiamo alla protezione degli animali attraverso le leggi dello Stato. All’articolo quarantuno è stato precisato che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che l’attività economica, pubblica e privata, deve essere indirizzata e coordinata anche a fini ambientali. È una svolta significativa, perché porta l’ambiente al centro della Costituzione materiale e pone un limite chiaro allo sfruttamento del territorio in nome del solo profitto.
L’italica sensibilità ha radici lontane, a partire almeno dal santo patrono del nostro Paese. Francesco d’Assisi non può essere definito ambientalista nel senso contemporaneo, ma il suo Cantico delle Creature, primo testo poetico della nostra lingua, affida alla natura una dignità che la scienza ecologica riconoscerà solo secoli più tardi. Il sole, la luna, l’acqua e il fuoco non sono oggetti da usare. Sono presenze con cui l’uomo intrattiene un rapporto di fraternità e responsabilità. La figura di Francesco ricorda che il rapporto con il paesaggio, nella tradizione di questo Paese, non è mai stato soltanto estetico o utilitaristico. È un senso di appartenenza. Una forma di cittadinanza estesa anche al mondo naturale.
Dalla Commedia di Dante ai paesaggi interiori di Petrarca, dai trattati di Leonardo ai versi di Leopardi e Pascoli, fino al ruolo del paesaggio nella poesia di Andrea Zanzotto e al cinema di Antonioni e Pasolini, l’Italia ha costruito nel tempo una cultura che percepisce il paesaggio non come cornice, ma come protagonista della vita collettiva e di identità. Esiste una ricchissima tradizione italiana di riflessione culturale sui luoghi e il paesaggio, anche se è solo nel Novecento (tralasciando iniziative locali pre-unitarie che pure ci sono state da Nord a Sud) che questa sensibilità diventa anche diritto positivo. Nel 1922 Benedetto Croce fece approvare la legge per la tutela delle bellezze naturali, che proteggeva i luoghi in sé e non soltanto i monumenti. È considerata ancora oggi l’atto fondativo della moderna coscienza ambientale nel diritto italiano.
Pochi decenni dopo Giorgio Bassani, scrittore e presidente di Italia Nostra, fece della difesa del paesaggio una questione culturale nazionale. Il suo contributo è fondamentale poiché l’intuizione portata avanti era quella di difendere il paesaggio come parte dell’essere italiani, ovvero come patrimonio “culturale”. Sosteneva, a giusto titolo, che ambiente e cultura formano un intreccio che caratterizza il nostro Paese e lo rende unico.
I borghi in equilibrio sulle colline appenniniche, le campagne vitate che modellano i pendii, la varietà dei prodotti regionali che nascono dalla relazione con un territorio preciso, le cave di marmo di Carrara che hanno nutrito il Rinascimento. Tutto questo non è un ornamento ma una forma concreta della nostra identità collettiva. La cura per i luoghi diventa così una responsabilità verso la memoria e verso la comunità che li abita.
Leggi anche: