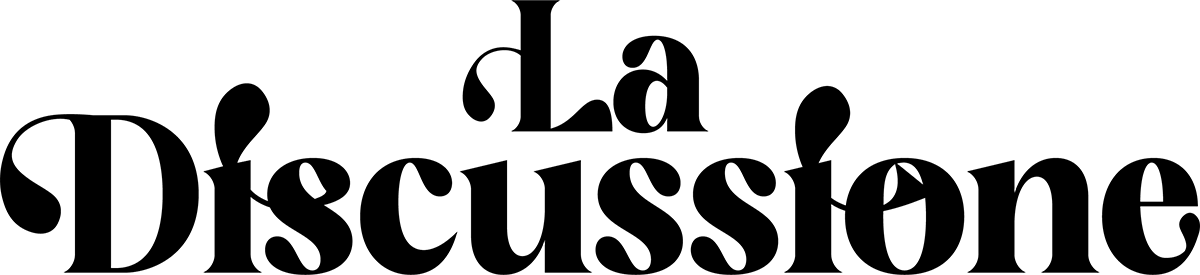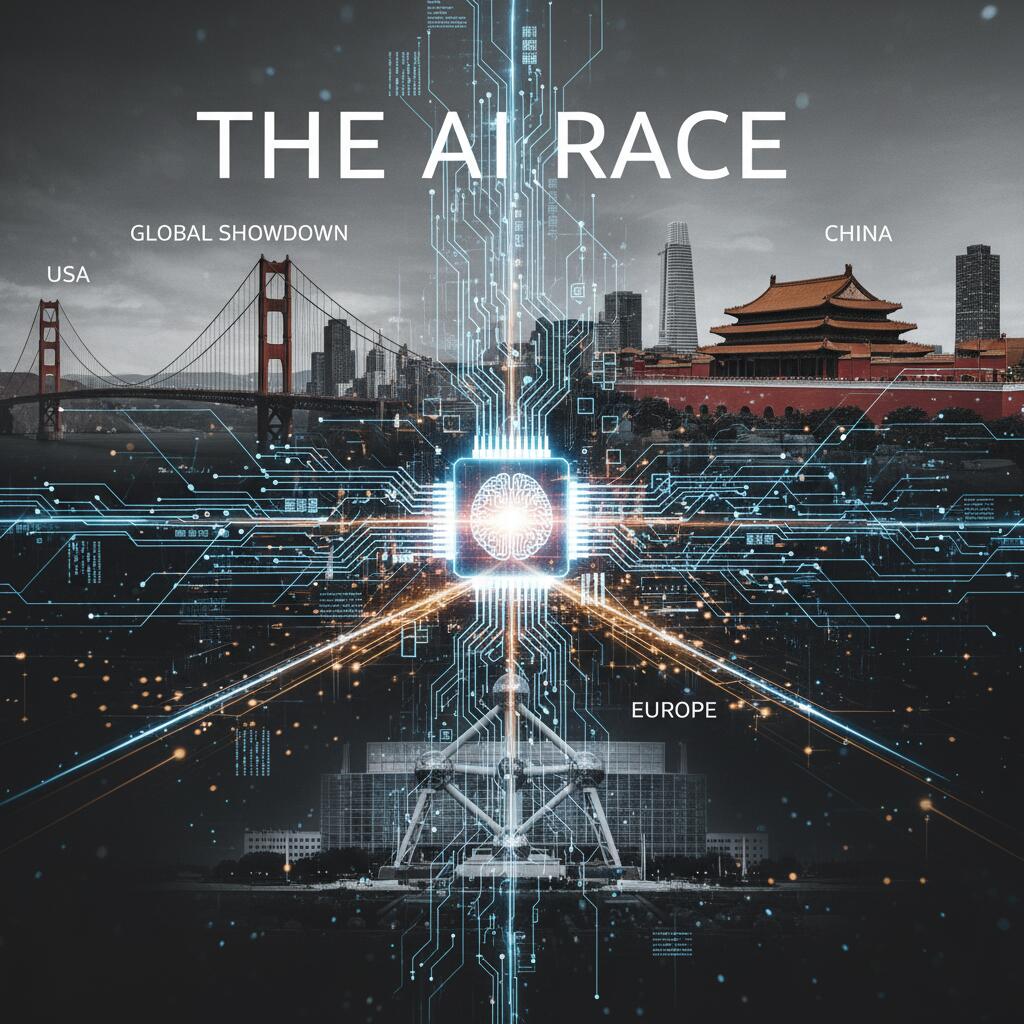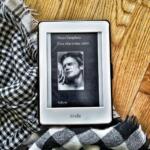Marco Camisani-Calzolari, il noto volto di “Striscia la notizia” cui è affidato il compito di aggiornarci sulle novità, rischi e vantaggi compresi, del mondo high tech, ci avvisa che l’aria che si respira nel settore dell’AI non è più quella di una semplice innovazione, una “bolla “speculativa che si potrebbe sgonfiare, ma di un vero e proprio processo di “sostituzione”. “L’AI – scrive in un post su Linkedin -, non aggiunge: cancella e rimpiazza. E se oggi ci sembra comodo chiedere ‘mi consigli un prodotto?’, domani ci accorgeremo che abbiamo smesso di scegliere. Quindi sì, preparatevi. Perché l’AI non sta arrivando: sta già riscrivendo Internet e questa volta non ci sarà un ‘dopo’”.
In altre parole quello che sta dicendo è che assisteremo a un cambio di specie nel DNA di Internet. L’Intelligenza Artificiale non si sta semplicemente diffondendo sulla rete, ma la sta divorando dall’interno, settore dopo settore, riscrivendo le regole fondamentali della navigazione e del consumo.
Dalla ricerca al monologo
Per vent’anni, Google è stata l’indiscussa porta d’ingresso a Internet attraverso i suoi motori di ricerca in cui si scrivevano le parole chiave per essere rimandati a una miriade di link, fonti e punti di vista. Ma oggi, che le persone non cercano più, ma chiedono, la query è diventata una conversazione: “Quale portatile mi consigli per lavorare in viaggio?”. E la risposta non è più una lista di dieci link, ma un’unica, coesa, sintetica risposta generata da un’AI.
Per sopravvivere anche Google ha dovuto trasformarsi in un’intelligenza artificiale, pena l’irrilevanza. Di conseguenza quando cerchiamo non stiamo più navigando tra le pagine del web, stiamo parlando con una macchina che, in base ai suoi algoritmi, decide cosa mostrarci, agendo da filtro e curatore universale.
Instant Checkout: quando l’AI si mangia l’e-commerce
Il prossimo passo dell’AI prevedibilmente sarà il commercio elettronico. L’annuncio negli Stati Uniti della partnership tra Walmart e OpenAI, creatrice di ChatGPT, è un chiaro segnale di ciò che sta per accadere. Presto l’atto di acquistare non richiederà più di lasciare la chat o aprire un browser, perché l’intero ciclo di acquisto avverrà direttamente dentro la conversazione.
Questo si chiama “Instant Checkout” o “Commercio Conversazionale”: si digita “regalo per mio padre” e si può completare la transazione immediatamente. L’AI bypassa così l’interfaccia dell’e-commerce, le categorie di prodotto, i filtri e l’atto stesso di scegliere. Questo non è un semplice upgrade, è l’inizio della nuova Internet.
La forza dell’AI è la “cura finta”
La vera rivoluzione, tuttavia, è legata all’assistenza clienti e alla fiducia. La forza di un colosso come Amazon, scrive ancora Camisani-Calzolari, non è mai stata solo nella logistica, ma nella customer satisfaction: rimborsi rapidi, risposte immediate, la sensazione di essere al centro dell’esperienza. Se l’AI è in grado di replicare questa sensazione di cura, anche se generata artificialmente (una “cura finta”), il ciclo di divoramento è completo: ricerca (l’AI risponde); acquisto (l’AI vende); assistenza (l’AI risolve il problema). Tutto avviene all’interno di un’unica, ininterrotta conversazione.
Una sola interfaccia per il mondo
A questo punto, la natura stessa di Internet subisce una mutazione. Non sarà più un luogo di esplorazione, dove l’utente è attivo e cerca i contenuti. Diventerà un ambiente coeso dove si parla con un’intelligenza che, essenzialmente, sceglie per noi. L’Internet frammentato di siti web e link, dei blog e dei forum, viene sostituito da un’unica, iper-efficiente interfaccia. La porta d’accesso al digitale si riduce a una sola.
Questo monopolio dell’interfaccia è l’obiettivo finale delle poche aziende che stanno guidando la corsa. OpenAI è in vantaggio, ma Google e Amazon sono vicinissime, tutte determinate a diventare l’unico e insostituibile intermediario tra l’essere umano e la totalità della conoscenza e del commercio digitale.
L’equivoco del nome “Intelligenza”
Il problema resta, dunque, sempre e solo la consapevolezza. Lo ricorda nel suo ultimo libro “L’intelligenza artificiale non pensa: agisce. E lo fa ovunque” anche il professor Luciano Floridi, filosofo tech all’Università di Yale: “Malgrado sia molto efficiente, l’intelligenza artificiale non pensa, non capisce, non è una mente. È altro: è agency, ossia ha capacità di agire nel mondo in modo efficace, senza possedere alcuna intelligenza. Potente, sì. Ma non viva”. “Non siamo davanti – prosegue il professore in una trasmissione radiofonica – a una semplice invenzione tecnologica. L’intelligenza artificiale è diventata la forza che sta riscrivendo le regole del presente: lavora, parla, osserva, decide. Entra nelle aziende, nelle scuole, nei governi, nelle nostre relazioni. Eppure, più avanza, più cresce una domanda: è davvero intelligente? No, non lo è. Siamo noi che la stiamo fraintendendo”.
In buona sostanza probabilmente continueremo ancora molto tempo a pagare l’equivoco ingenerato dal nome scorretto dato nel 1956 nella Conferenza di Dartmouth a questa nuova tecnologia: “intelligenza”. L’errore è stato segnalato da molti specialisti di varia formazione e di diverso orientamento, come l’informatico Alfio Ferrara, che ha spiegato bene al pubblico italiano come anche gli esperti di questo campo di studi considerino l’etichetta in sostanza impropria, sebbene la utilizzino negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, essenzialmente per “un problema di marketing”. Cioè perché si tratta di una formula che oggi vende.
E non si tratta di una pura e oziosa questione terminologica. Secondo Lorenzo Tomasin, Accademico della Crusca, “la parola intelligenza e il suo campo semantico sono indubitabilmente dotati di una connotazione generalmente positiva: dire che una persona è molto intelligente significa, in linea di massima, esprimere un apprezzamento. E l’aggettivo intelligente riferito a pratiche o a oggetti ne indica generalmente una qualità positiva e desiderabile, che li rende migliori rispetto a ciò che essi sono in assenza di quel requisito specifico”.
E ricordiamoci che già Galileo Galilei, anche egli accademico della Crusca, affermava che “i nomi e gli attributi si devono accomodare all’essenza delle cose e non l’essenza ai nomi”. Perché se forma e sostanza si sovrappongono, rischiamo in questo specifico caso di non usufruire di un nuovo strumento tecnologico, ma piuttosto di subirlo.