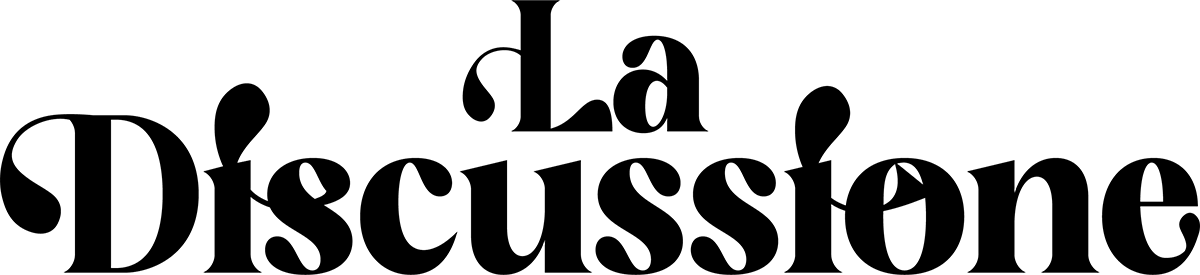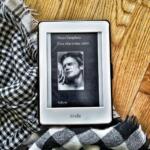Le bambine non giocano più a truccarsi. Si truccano davvero. Entrano nei negozi di make-up con lo stesso entusiasmo con cui le loro mamme a quell’età entravano in un Disney Store. A dieci anni non comprano bambole, ma sieri alla niacinamide, creme anti-età, fondotinta. Se Louisa May Alcott fosse nata ai giorni nostri avrebbe scritto “Piccole donne” , per celebrare un’infanzia abbandonata troppo presto in favore di un rituale che appartiene a ben altra maturità. E c’è addirittura chi si spinge oltre, ricorrendo a veri ritocchi estetici.

Le chiamano “Sephora Kids”, bambine ossessionate da skincare, filler e cura del corpo, un fenomeno a dir poco sconcertante per chi le osserva dall’esterno chiedendosi cosa ci sia da rimpolpare o ringiovanire a quell’età. Questa sembrerebbe essere la nuova generazione, che salta l’adolescenza per tuffarsi direttamente nell’adulta ansia estetica. Come spiega l’antropologa Rachele Perrini, “l’ossessione estetica che oggi caratterizza molte preadolescenti, spesso sostenute o addirittura spinte dalle madri, non è un fenomeno marginale: è il riflesso di una trasformazione profonda nella costruzione del femminile. La bellezza non è più un piacere, ma una forma di legittimazione”.
Ad avvisarci dei rischi di queste esagerazioni non mancano, poi, le tragedie riportate dalla cronaca nera, come il recente caso della ragazza di 14 anni morta sotto i ferri durante un intervento estetico in Messico. Si trattava di una mastoplastica additiva e di un lifting ai glutei, a quattordici anni e con il sostegno della madre. È una notizia che dovrebbe far riflettere tutti, in primis genitori, medici ed educatori.
La bellezza precoce che fa crescere i fatturati
D’altra parte il fatturato delle imprese italiane della cosmetica supera i 16,5 miliardi, con una crescita del 9,1% (dati Cosmetica Italia). Si fa allora presto a comprendere perché il mercato tenda ad ampliare il target di riferimento. I prodotti skincare rappresentano circa il 16% dei consumi totali e tra questi non mancano quelli dedicati alle più piccole, dai detergenti alle creme, fino ai mini kit di make-up. Le aziende puntano su consumatrici sempre più giovani e le madri spesso li acquistano senza riflettere, percependo questi prodotti come innocui o addirittura educativi.
Ma non si parla solo di cosmesi. Secondo una ricerca dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro il 49,2% degli adolescenti tra i 13 e i 18 anni vorrebbe ricorrere alla medicina estetica, mentre il 31,3% prenderebbe in considerazione la chirurgia vera e propria. Un desiderio di trasformazione che non nasce da un bisogno clinico, ma da un senso di inadeguatezza coltivato fin dall’infanzia, quando l’accettazione dovrebbe far parte del processo di crescita.
La madre di ieri e oggi

Spesso dietro le pressioni estetiche precoci sulle bambine ci sono proprio le madri, le cosiddette “mammager”, che spingono le figlie a esaltare le proprie qualità estetiche, soprattutto sui social. Nel migliore dei casi le trattano come bamboline da sfoggiare, nel peggiore come macchine da soldi. Negli Stati Uniti, con la lunga lista di baby star sfruttate dai genitori fino ai limiti della salute mentale, questo fenomeno è particolarmente evidente. Le madri, cresciute in un mondo che ha insegnato loro a “valere” attraverso l’aspetto, trasmettono alle figlie quel medesimo codice simbolico. Secondo la dottoressa Perrini “la madre, spesso in modo inconsapevole, tende a proiettare sulla figlia la propria ricerca di riconoscimento sociale, trasformandola in un’estensione di sé”.
Un meccanismo che Visconti già raccontava nell’indimenticabile film, interpretato da Anna Magnani, “Bellissima”. La protagonista, Maddalena Cecconi, spinge la figlia verso il mondo del cinema, convinta che talento e bellezza possano offrirle un riscatto sociale che lei stessa non ha avuto. Oggi, molte madri sembrano replicare lo stesso schema. Come Maddalena in “Bellissima” rischiano di voler realizzare se stesse attraverso le figlie, dimenticando che crescere significa rispettare tempi e desideri autentici di chi sta diventando grande.
Così, l’infanzia viene precocemente esposta al linguaggio adulto della competizione estetica e il gioco lascia spazio a una vera e propria disciplina estetica. Questa esposizione continua al giudizio altrui genera una frattura tra il corpo vissuto e il corpo mostrato: “La bambina – dice Perrini – non si percepisce più dall’interno, ma attraverso lo sguardo dell’altro. Questa continua mediazione visiva può produrre, nel tempo, un senso di inadeguatezza cronico”. La dimensione affettiva del sé, quella che nasce dal contatto con il corpo reale, cede il posto a una logica performativa: “Mi sento bene se piaccio”.

Anche i social media contribuiscono, amplificando questo meccanismo. I “like” diventano una forma di approvazione affettiva, mentre la madre, spesso convinta di celebrare la figlia, contribuisce in realtà a inserirla in un circuito di giudizio permanente. Secondo l’esperta “è così che l’infanzia si accorcia: la leggerezza del gioco viene sostituita dalla disciplina dell’immagine e la libertà di essere diventa presto la necessità di piacere”.
Secondo l’antropologa il rischio maggiore non è estetico, ma affettivo: “Una generazione di ragazze che sanno farsi vedere, ma non sanno più riconoscersi”. Il messaggio è chiaro: educare alla bellezza non deve diventare educare alla competizione estetica. Solo così le bambine possono imparare a valorizzarsi senza sentirsi costantemente giudicate. Il film “Bellissima” già mostrava come questo schema, il desiderio di realizzare ambizioni adulte attraverso i figli, non sia nuovo, ma oggi, amplificato dai social, assume dimensioni pervasive e quotidiane. Solo valorizzando l’essere anziché l’apparire le bambine potranno imparare a riconoscersi, vivere la propria infanzia e crescere libere.