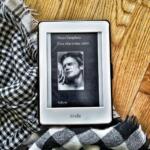La depressione nei bambini, solitamente diagnosticata tra i 3 e i 5 anni, è un disturbo emotivo e comportamentale che non va confusa con semplici momenti di tristezza o fasi passeggere, ma è una condizione clinica che potrebbe non essere immediatamente riconoscibile per le difficoltà che i bambini hanno a comunicare i propri sentimenti. Secondo la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA), il 25% dei bambini e adolescenti italiani soffre di depressione, una percentuale che peraltro continua ad aumentare. Il libro della psicologa Rosa Marì Castaldi, “La depressione infantile una malattia degli affetti”, offre un percorso di riflessione sul come lo stile di attaccamento agito dalle figure parentali costruisce la mappa del doloroso territorio della depressione.
Dottoressa, lei ha scritto un libro su una psicopatologia, la depressione infantile, che mal si concilia con la rosea visione collettiva che si ha della infanzia. È una eredità di questa epoca?
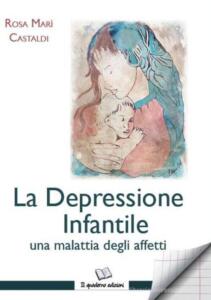 I primi cinque anni di vita del bambino sono i più importanti, perché si creano le strutture di base della piramide evolutiva della personalità. La mancanza di sincronia emotiva di riconoscimento dei bisogni psicologici del bambino determina i disturbi psicologici in età evolutiva che, nel nostro contesto storico-socio-culturale, sono effettivamente in aumento. I disturbi di personalità che si sviluppano nell’adolescenza e nell’età adulta sono l’evoluzione delle ferite affettive vissute nell’infanzia. In particolare mi riferisco al disturbo dell’attaccamento del tipo insicuro/disorganizzato che si può strutturare nei primi tre anni di vita del bambino e delle sue conseguenze traumatiche i cui sintomi affiorano nel tempo. Ciò accade in quelle famiglie in cui le relazione affettive con mamma e papà sono incongruenti, che non danno risposte ai bisogni psicologici del bambino e risultano genitori inadeguati al compito richiesto dalla genitorialità.
I primi cinque anni di vita del bambino sono i più importanti, perché si creano le strutture di base della piramide evolutiva della personalità. La mancanza di sincronia emotiva di riconoscimento dei bisogni psicologici del bambino determina i disturbi psicologici in età evolutiva che, nel nostro contesto storico-socio-culturale, sono effettivamente in aumento. I disturbi di personalità che si sviluppano nell’adolescenza e nell’età adulta sono l’evoluzione delle ferite affettive vissute nell’infanzia. In particolare mi riferisco al disturbo dell’attaccamento del tipo insicuro/disorganizzato che si può strutturare nei primi tre anni di vita del bambino e delle sue conseguenze traumatiche i cui sintomi affiorano nel tempo. Ciò accade in quelle famiglie in cui le relazione affettive con mamma e papà sono incongruenti, che non danno risposte ai bisogni psicologici del bambino e risultano genitori inadeguati al compito richiesto dalla genitorialità.
Il fenomeno, come lei stesso scrive, sembrerebbe in aumento. Le cause sono di tipo ereditario o puramente ambientale?
Il disturbo affettivo del tipo disorganizzato può dare origine, così come dimostrano le più recenti ricerche, a una risposta comportamentale reattiva, la cui sintomatologia è comune in molti punti al comportamento presentato dal bambino con sindrome dello spettro autistico. In questo disturbo, quindi, non gioca l’ereditarietà, ma la modalità relazionale intra-familiare così come avviene anche per il disturbo del carattere e del comportamento.
Quali sono i sintomi che non si possono assolutamente ignorare?
Il pianto del bambino, il rifiuto del cibo, l’aggressività, l’enuresi notturna, il mutismo selettivo e altri ancora.
In che modo suggerisce a un genitore di intervenire?
Con la psicoterapia familiare che lavora con i genitori e con il bambino portatore della sintomatologia, per un percorso psicoterapeutico che amo definire “di consapevolezza” finalizzato a migliorare le modalità relazionali e comunicative, focalizzandosi sui comportamenti errati. Probabilmente bisognerebbe migliorare le competenze genitoriali sul piano affettivo, emotivo e relazionale, ridimensionando l’eccesso di materialismo che uccide i nostri bambini, poiché annulla ogni forma di desiderio e distrugge le passioni.
Che responsabilità hanno le figure della mamma e del papà?
Le figure della mamma e il papà sono fondamentali. Tuttavia giocano un ruolo importante anche altre figure come i nonni, le tate, cioè tutte le persone che mantengono un contatto significativo con un bambino che sta costruendo la base della sua personalità. Con la madre tale processo inizia già dal terzo mese di gravidanza. Col papà già dalla seconda settimana di vita, con l’incrociarsi dello sguardo padre/figlio, così come hanno dimostrato le ricerche sulla triangolazione primaria madre/padre/neonato. I genitori hanno un compito educativo/regolativo e devono fornire un adeguato supporto emotivo.
Visualizza questo post su Instagram