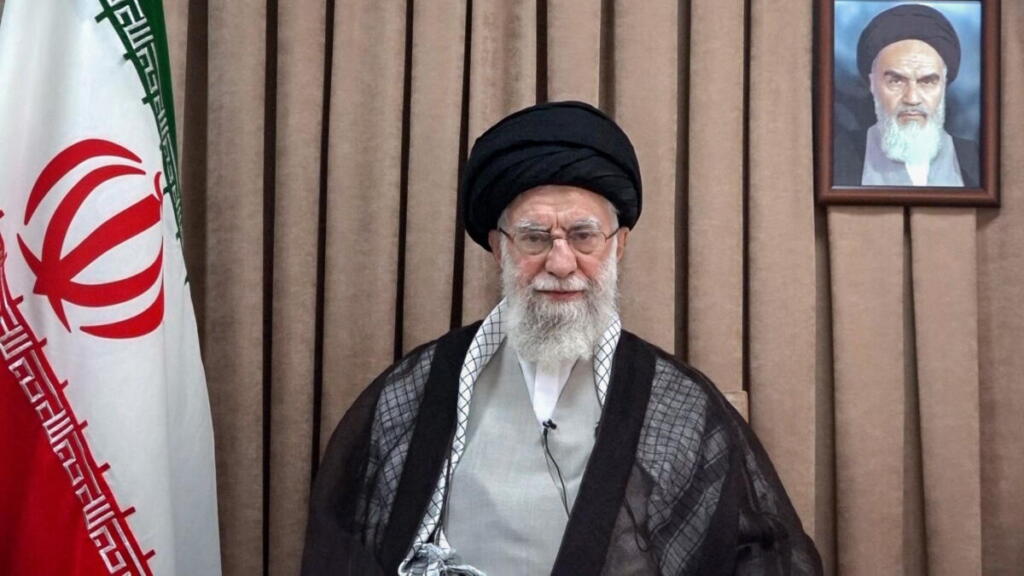Dal 1° gennaio del prossimo anno tutte le imprese private italiane saranno obbligate a stipulare una polizza catastrofale per proteggersi da eventi naturali estremi come alluvioni, frane e terremoti. Una decisione maturata dopo mesi di dibattito e confusione, mitigata solo parzialmente da un intervento dell’ultima ora del governo, che ha posticipato di qualche mese l’obbligo effettivo. Ma per molte imprese si tratta di una ‘toppa’ insufficiente: il problema di fondo resta, ed è tutto nei numeri. Secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, le imprese italiane versano già ogni anno circa 21 miliardi di euro in imposte ambientali allo Stato e agli enti locali. Risorse importanti che, almeno in teoria, dovrebbero servire anche a finanziare opere di prevenzione del dissesto idrogeologico: pulizia degli alvei fluviali, manutenzione degli argini, realizzazione di bacini di laminazione e casse di espansione. In pratica, però, queste opere vengono spesso trascurate o realizzate solo dopo che il disastro si è già verificato.
“Così le imprese si trovano a pagare due volte la protezione ambientale: una volta allo Stato, un’altra alle assicurazioni private”, denunciano gli artigiani veneti.
Polizze obbligatorie
L’obiettivo della nuova norma, spiegano dal governo, è ridurre i tempi di ristoro alle imprese colpite da eventi calamitosi. I rimborsi statali, infatti, arrivano spesso in ritardo — quando non troppo tardi, come dimostrano molti casi recenti in cui le attività hanno chiuso prima ancora di ricevere un euro di aiuto. Con l’assicurazione privata, almeno sulla carta, i tempi dovrebbero accorciarsi: qualche settimana, non mesi o anni. Un principio condivisibile, quello dell’efficienza, ma che lascia aperti interrogativi cruciali: perché le imprese devono continuare a pagare imposte ambientali così elevate, se poi la protezione ambientale viene privatizzata? Perché non si prevede una riduzione compensativa del carico fiscale? Il rischio concreto è che si inneschi una spirale insostenibile: più tasse e più oneri assicurativi, senza alcun beneficio in termini di prevenzione.
Nel 2022, i settori più colpiti dalle imposte ambientali sono stati quelli energivori (elettricità, gas, vapore) con 5,3 miliardi di euro, seguiti dall’industria manifatturiera (5 miliardi) e dai trasporti (3 miliardi). Solo questi tre comparti rappresentano il 63,7% del gettito totale. Le imprese del commercio e dell’edilizia seguono a ruota, con 2,2 e 1,4 miliardi rispettivamente.
In Europa
A livello europeo, l’Italia è seconda solo alla Germania per il gettito complessivo derivante dalle imposte ambientali: 54,2 miliardi di euro nel 2023, contro i 71,4 miliardi tedeschi. Eppure, se si rapporta questa cifra al PIL, l’Italia scivola all’ottavo posto con un’incidenza del 2,6%. Un dato comunque superiore a quello dei principali partner europei: la Francia è all’1,8%, la Germania all’1,7% e la Spagna all’1,6%. La media Ue è del 2%. In altre parole: le imprese italiane sono già tra le più tartassate d’Europa. Ora si chiede loro uno sforzo ulteriore, senza che lo Stato riduca le proprie pretese fiscali.
La questione si inserisce in un contesto più ampio: da oltre 25 anni, l’Italia assiste a un progressivo disimpegno dello Stato da settori chiave del welfare e dei servizi pubblici, dalla sanità alla previdenza, dalla sicurezza alla protezione ambientale. L’arretramento della sfera pubblica ha aperto la strada a un crescente protagonismo dei soggetti privati, comprese le compagnie assicurative.
Questa evoluzione può anche essere accettata come scelta politica legittima. Ma se i privati subentrano allo Stato nella gestione dei rischi e dei servizi, è logico attendersi una contropartita: una riduzione delle imposte. Invece, accade l’opposto. Le tasse ambientali, specie quelle locali, sono tornate a crescere negli ultimi anni, alimentate dalla necessità degli enti territoriali di chiudere i bilanci in pareggio.
A rischio la competitività
Insomma, secondo la Cgia il nuovo obbligo assicurativo, senza una parallela riduzione del carico fiscale, rischia di diventare l’ennesimo colpo alla competitività delle imprese italiane. Le realtà più piccole, già schiacciate dall’inflazione, dall’aumento dei costi energetici e dalle rigidità burocratiche, faticheranno a reggere l’ennesimo balzello. C’è poi il nodo dell’incertezza normativa: il regolamento attuativo, pubblicato solo alla fine di febbraio in Gazzetta Ufficiale, ha contribuito a generare confusione tra gli operatori. Mancano ancora chiarimenti su tempi, modalità, parametri di rischio, premi assicurativi. Il rischio è che, come spesso accade, le norme finiscano per penalizzare soprattutto chi rispetta le regole.