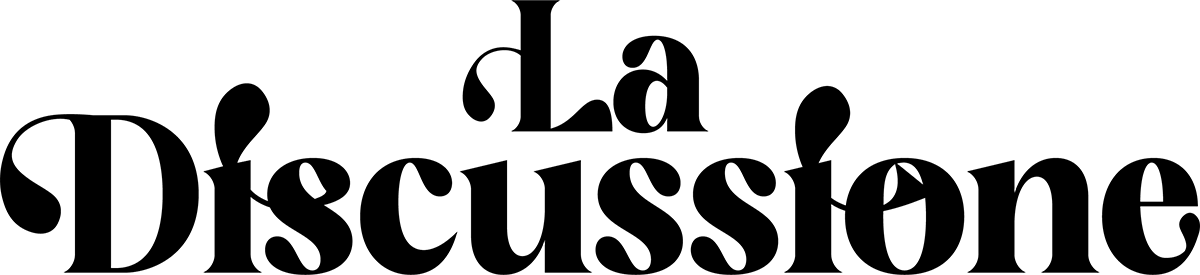Nel cuore del Vulture, nella città che fu cara a Federico II, è riemerso un pezzo di storia dell’arte che potrebbe riscrivere un capitolo dimenticato del Seicento italiano. Il Museo Diocesano di Melfi custodiva da anni un quadro anonimo arrivato da Napoli, raffigurante un “Ecce Homo — Cristo coronato di spine” le mani legate e lo sguardo rivolto al suolo. Ora quello stesso dipinto è stato attribuito con sicurezza al Domenichino, pseudonimo di Domenico Zampieri (Bologna, 1581 – Napoli, 1641), allievo dei Carracci e interprete elegante della spiritualità barocca.
Il riconoscimento, siglato l’11 dicembre 2025 tra lo storico dell’arte Mauro Di Ruvo e monsignor Ciro Guerra della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, rappresenta la conclusione di un’indagine durata mesi. Si tratta di una scoperta che entusiasma i critici. La tela colma, infatti, un vuoto nel catalogo del pittore bolognese, di cui non era nota alcuna versione del celebre tema dell’”Ecce Homo”.
Un mistero lungo quattro secoli
Già negli anni Ottanta del Novecento si parlava di un possibile “Ecce Homo” del Domenichino. Vittorio Sgarbi ne ipotizzò l’esistenza in una monografia su Caravaggio, ma nessuno lo aveva mai individuato. Lo stesso Roberto Longhi, massimo studioso del barocco, lo considerava un soggetto estraneo alla sensibilità di Zampieri.
La svolta è arrivata a partire dal settembre 2025, quando Di Ruvo ha iniziato a rileggere l’opera con strumenti filologici e comparativi. L’opera, donata nel 1973 alla Diocesi dalla signora Anna Aurelio di San Giorgio a Cremano e proveniente da una famiglia aristocratica della Riviera di Chiaia, è rimasta per decenni nell’ombra, fino al riesame che ha rivelato evidenti coincidenze stilistiche con i lavori napoletani dell’ultimo Domenichino. In particolare, con il ciclo di affreschi della Cappella del Tesoro di San Gennaro, realizzato tra il 1631 e il 1640 per il viceré Zúñiga y Fonseca.
Uno stile tra dramma e devozione
Il dipinto di Melfi presenta un Cristo coronato di spine a mezzo busto, circondato da un fondo terroso e immerso in una luce calda e trattenuta, che regge lo scettro della derisione. Niente teatralità caravaggesca, ma una dolce intensità che richiama la spiritualità di Guido Reni, amico e rivale di Zampieri. Dietro il volto di Cristo emergono due angeli sfumati, quasi sospesi fuori dal tempo narrativo, figure che rimandano alla tradizione del Rinascimento, ma annunciano già la pittura devozionale del Settecento.
“Il volto — spiega Di Ruvo — unisce la perfezione formale di Raffaello e la quiete malinconica che contraddistingue il Domenichino maturo. La resa del collare sanguigno, il taglio a mezzo busto, la solitudine del Cristo sono elementi che avvicinano l’opera tanto a Roma quanto a Napoli, nel momento di transizione tra Classicismo e Nuovo naturalismo”.
Un ritratto del Seicento napoletano
La datazione suggerita, tra il 1639 e il 1640, poco prima della morte dell’artista, colloca l’opera nell’ultimo periodo napoletano del Domenichino, quando la sua pittura si fece più intima e drammatica. L’“Ecce Homo” dialoga idealmente con le composizioni di Caravaggio, le figure mistiche di Ribera e i cieli sofferenti del giovane Artemisia Gentileschi. Ma qui la violenza è assente, la sofferenza è interiore, trattenuta. Cristo non è più un corpo martoriato, ma un uomo dignitoso nella sua solitudine, in bilico fra umano e divino.
L’opera si trova esposta nel museo di Melfi nella cornice originaria del XVII secolo, a livello dello sguardo, quasi a invitare il visitatore a un incontro diretto con il volto del dolore.
Un capolavoro riscoperto nel silenzio
Per Di Ruvo questa scoperta non è “un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di ricognizione”, perché l’“Ecce Homo” di Melfi potrebbe essere la chiave di lettura per altre opere inedite sul medesimo soggetto in ambito bolognese e romano. Secondo gli studiosi, la scoperta rimette in discussione anche l’immagine stessa del Domenichino, non solo pittore “classico” e devoto, ma interprete dei moti interiori più umani, capace di tradurre la controriforma in un linguaggio di compassione universale.
Un nuovo sguardo sulla pittura barocca
Nel panorama del Seicento italiano, segnato dalle ombre di Caravaggio e dalla potenza dei Carracci, il Domenichino è sempre stato considerato la voce più lirica, quella che predilige l’armonia all’eccesso. Il ritrovamento di Melfi restituisce a quella voce un tono più intimo e moderno, anticipando quella dimensione psicologica che diverrà essenziale nell’arte europea.
Così, in una piccola città lucana, un dipinto rimasto per anni a margine della storia torna oggi a far parlare di sé: un Cristo sofferente, ma non sconfitto, ultimo atto poetico di un artista che cercò per tutta la vita, e forse finalmente trovò, un equilibrio tra la grazia di Raffaello e la luce inquieta di Caravaggio.