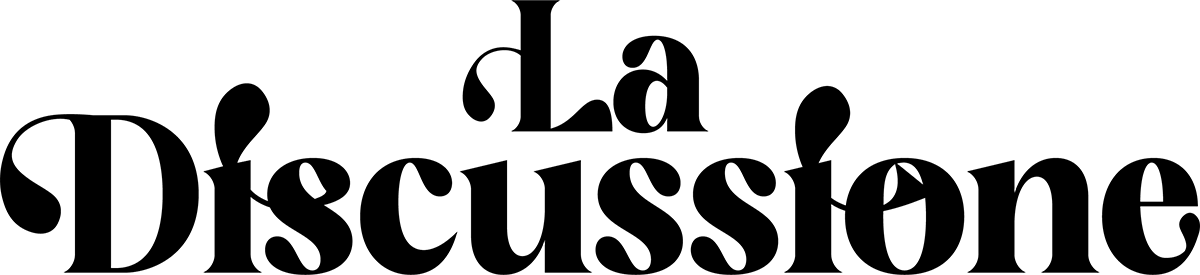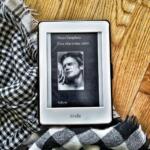Il ritiro sociale giovanile è un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia. Conosciuti come Hikikomori, giovani che scelgono di tagliare ogni contatto con il mondo esterno e di vivere nella propria stanza, trascorrono le giornate online. Si tratta di un disagio complesso, che intreccia fattori personali, familiari e sociali. Spesso i primi campanelli d’allarme vengono scambiati per semplice ribellione adolescenziale, finché la chiusura non diventa totale. Secondo lo psicologo sociale Marco Crepaldi, fondatore dell’associazione Hikikomori Italia, il ritiro non avviene all’improvviso, ma si verifica gradualmente nel tempo.
“Tre segnali precoci nelle famiglie – spiega Crepaldi – indicano che un ragazzo potrebbe isolarsi: il rifiuto di tutte le attività extrascolastiche, in primis lo sport, ma anche tutte quelle attività sociali che non sono percepite come obbligatorie. La scuola, seppur mantenuta in una prima fase, manifesta già una certa difficoltà nell’essere gestita come ansia: ci sono rifiuti saltuari con una certa costanza che il ragazzo cerca di evitare, non per forza in concomitanza di verifiche o valutazioni, ma anche proprio per l’ansia di recarsi in aula. A questi segnali si accompagna, poi, un aumento dell’abuso delle nuove tecnologie, che diventano l’unico canale di contatto con l’esterno, così come un’inversione del ritmo sonno veglia e in generale un abbassamento del tono dell’umore con una crescente irritabilità”.

Anche le relazioni familiari giocano un ruolo cruciale. Quando in casa domina un clima iperprotettivo o troppo rigido il giovane può sentirsi intrappolato tra aspettative irrealistiche e mancanza di ascolto. Per lo psicologo “due fattori possono favorire il ritiro sociale: l’iperprotezione e l’idealizzazione, un mix di eccessive cure e di aspettative molto elevate sui figli. Lo stile autoritario, soprattutto paterno, ma talvolta anche materno, interferisce con una connessione emotiva che permette ai figli di imparare a comunicare anche emotivamente le proprie ansie e paure”. Indubbiamente, la difficoltà di instaurare un dialogo autentico con i genitori amplifica il senso di solitudine. “Un rapporto poco emotivo, poco profondo con i genitori va ulteriormente a disincentivare la capacità del ritirato di ammettere di avere un problema”.
Per questo Crepaldi sottolinea l’importanza di un approccio familiare basato sull’ascolto e sulla fiducia reciproca: “Cercare di non proiettare eccessive aspettative, favorire una spinta all’autonomia, rappresentare degli interlocutori emotivi favorevoli e alleati: sono tutte strategie che aiutano. Il figlio non deve percepire il genitore come una fonte di pressione sociale da cui fuggire”. Molti genitori, invece, reagiscono con durezza, senza comprendere la natura del disagio, aggravando così la distanza emotiva: “Sicuramente tutti quegli atteggiamenti coercitivi – staccare internet, minacciare, mettergli paura, frasi del tipo ‘ma se non vai a scuola cosa farai nella vita, finirai sotto un ponte’ o ‘se non esci con gli amici poi rimani solo’ – contribuiscono ad aumentare la sua paura percepita e, quindi, favoriscono ancora di più l’isolamento. Bisogna invece dare speranza, tranquillità, infondere fiducia nel futuro e nella società”.

Quando la vita si riduce allo spazio virtuale significa che il ritiro è ormai profondo. “Vuol dire che siamo in una fase molto avanzata del problema, una fase cronicizzata grave. Bisogna interessarsi a quello che il giovane vive online, cercare di capire come passa il tempo, perché molti Hikikomori utilizzano il web fondamentalmente per non pensare più”. In questo scenario i fratelli e le sorelle possono diventare figure chiave di mediazione e supporto: “Spesso hanno maggiori competenze nel riuscire a entrare in contatto emotivo con i ritirati, hanno la capacità magari di prendere contatto anche online con servizi come la nostra associazione. Possono svolgere un ruolo di mediazione tra i genitori e il giovane, almeno finché fanno parte del nucleo familiare”.
Il fenomeno in Italia si intreccia con quello dei NEET (oltre 1,3 milioni di giovani che non studiano né lavorano né cercano lavoro). “I pre-Hikikomori – spiega ancora Crepaldi – sono coloro che vanno ancora a scuola, ma che sono isolati per tutto il resto del tempo. Questi non sono tecnicamente NEET, ma sono comunque già molto ritirati e a grave rischio di cronicizzazione, mentre la stragrande maggioranza degli Hikikomori cronicizzati, cioè quelli post-abbandono scolastico e lavorativo, sono NEET”.
Il percorso di reinserimento non può prescindere da un lavoro sull’intero contesto familiare e scolastico. E’ necessario “sicuramente l’intervento sistemico, lavorare su tutta la famiglia, perché i ritirati stessi spesso non accettano un aiuto. L’intervento educativo domiciliare può essere un gancio importante, così come il rapporto con la scuola e l’attivazione di un piano didattico personalizzato. In generale, una sensibilizzazione pubblica del problema aiuta”.
Le emozioni dei genitori oscillano tra senso di colpa, paura e speranza. “C’è un forte senso di colpa, soprattutto in una fase iniziale, perché si pensa di essere gli unici a vivere un’esperienza del genere. Poi si capisce che è un fenomeno che riguarda tante persone. C’è ansia, frustrazione, impotenza, ma anche speranza, disillusione ed elementi positivi legati ai contatti con i figli”. Talvolta, però, la disperazione può portare a gesti estremizzati, che possono portare anche a epiloghi tragici: “In senso negativo c’è chi ha staccato la luce pur di non farlo giocare al computer, chi ha tolto la porta della camera da letto. C’è stato un caso a Udine di una mamma che ha tolto la tastiera al figlio che stava giocando e questo si è lanciato dalla finestra. Ci sono stati casi di violenza sia dei genitori verso i figli sia dei figli verso i genitori”.
Nonostante tutto, esistono anche percorsi di rinascita, spesso legati a un cambiamento profondo nel modo di stare in relazione. “Ho visto anche cambiamenti profondi – conclude Crepaldi –: genitori che si sono messi in discussione, hanno accettato il figlio per com’era e ragazzi che ne sono usciti soprattutto grazie a passioni artistiche”. Anche ripensare culturalmente il modo in cui la società misura il valore individuale può aiutare: “Bisogna eliminare l’ansia del rimanere indietro, la paura del buco nel curriculum. Dobbiamo normalizzare il fatto che si possa stare male, che la salute mentale è precaria e dare la sensazione di potersi rimettere in corsa”.