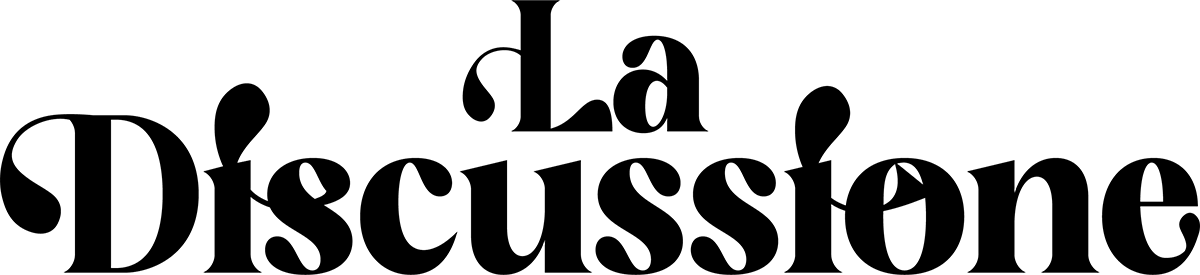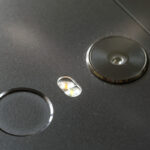Negli ultimi anni, con la diffusione delle relazioni nate e coltivate attraverso i social network e le app di incontri, si è affermato un fenomeno tanto diffuso quanto discusso: il ghosting. Il termine deriva dall’inglese to ghost (“svanire come un fantasma”) e indica l’interruzione improvvisa e immotivata di ogni comunicazione con una persona, senza spiegazioni né preavvisi. Se sul piano sociale ed emotivo il ghosting è ormai riconosciuto come una pratica dolorosa e destabilizzante, una forma di violenza psicologica che lascia l’altra persona senza strumenti per elaborare la fine del rapporto, sul piano giuridico la questione è più complessa.
Cos’è e come si inserisce nel diritto italiano
Il ghosting si verifica quando una persona, solitamente in un contesto affettivo o sentimentale, sparisce all’improvviso: smette di rispondere a messaggi, telefonate, blocca l’altra parte sui social e tronca ogni forma di contatto, lasciando l’altro/a senza alcuna spiegazione. Questo comportamento può generare forte ansia, senso di rifiuto e in alcuni casi veri e propri traumi psicologici. Attualmente, il ghosting non è previsto come reato autonomo nel codice penale italiano, non esiste cioè un articolo del codice penale che lo punisca direttamente ma, in certe situazioni estreme, può incrociarsi con altre fattispecie previste dalla legge.
I reati previsti dal codice penale
Insomma, non è il “fantasma” in sé a essere punito, ma gli effetti che la sua sparizione, o i comportamenti collegati, provocano. Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), nel caso in cui alla fase di sparizione segua un comportamento ambiguo, fatto di apparizioni e sparizioni strategiche per destabilizzare la vittima (breadcrumbing). Stalking (art. 612-bis c.p.), se il ghosting si accompagna a ripetuti atti persecutori, minacce o condotte che cagionano grave stato di ansia e paura. Violenza psicologica in ambito civile e familiare, quando la condotta di ghosting rientra in un quadro di maltrattamenti (art. 572 c.p.). Diffamazione (art. 595 c.p.) se accompagnato da condotte denigratorie nei confronti della persona “ghostata”. Abbandono di incapace (art. 591 c.p.), nel caso in cui il ghosting avvenga nei confronti di una persona incapace, malata o bisognosa di assistenza. Allargando il campo alla sfera professionale si possono anche ipotizzare l’interruzione di pubblico servizio o di comunicazioni ufficiali (art. 340 c.p.), se il ghosting si verifica tra soggetti che ricoprono ruoli pubblici o di responsabilità; frode contrattuale (art. 640 c.p.), se il ghosting si verifica dopo la stipula di un contratto; omessa assistenza (art. 593 c.p.), qualora si abbandoni una persona in pericolo senza intervenire.
La responsabilità civile
Anche se non configurabile come reato, il ghosting può aprire la strada a richieste di risarcimento danni, soprattutto laddove siano documentabili effetti lesivi sulla salute psicologica. Se, poi, il silenzio causa danni patrimoniali o morali, nel caso, ad esempio, di un professionista che sparisce senza consegnare un lavoro pagato, la parte lesa potrebbe agire per il risarcimento del danno, invocando l’inadempimento contrattuale o l’illecito extracontrattuale.
Il dibattito sul “reato di ghosting”
Al di là delle aule giudiziarie, il ghosting rappresenta uno specchio della società digitale: relazioni più veloci, più fragili e meno basate sul confronto diretto. L’anonimato e la disintermediazione dei social facilitano atteggiamenti di fuga, che in passato erano più difficili da attuare. In questo senso, il ghosting si inserisce in un più ampio dibattito sulle nuove forme di violenza relazionale, non fisica ma psicologica, e sull’impatto che la tecnologia ha nei legami umani. Per questo alcuni parlamentari italiani hanno proposto di introdurre una disciplina specifica sul ghosting, riconoscendolo come forma di violenza psicologica digitale, in particolare nelle relazioni affettive. Le ragioni di questa proposta sono legate alla crescente diffusione del fenomeno e agli effetti negativi sulla salute mentale delle vittime. Tuttavia, la questione è controversa: c’è che vuole evitare derive punitive che possano limitare la libertà di porre fine a un rapporto e chi ritiene giusto tutelare chi subisce danni psicologici da comportamenti relazionali lesivi. La sfida sarà trovare un equilibrio tra libertà individuale e tutela della dignità della persona, soprattutto nell’era delle relazioni digitali.
Le cause
Il ghosting racconta molto della nostra società. Relazioni sempre più veloci, leggere e “usa e getta”, dove spesso è più facile premere “blocca”, che affrontare un confronto diretto. Un comportamento che, a lungo andare, rischia di normalizzare la fuga invece del dialogo. I motivi più comuni possono essere la paura del confronto, il disinteresse o perdita di interesse, l’ansia e insicurezza personale, relazioni superficiali e digitali.
Molte persone non riescono a gestire un dialogo difficile, come dire “non mi interessa” o “non voglio continuare”. Per timore di ferire o per evitare conflitti preferiscono sparire. L’altra persona non più coinvolta emotivamente, non trova cioè la voglia di spiegarne i motivi. Chi fa ghosting spesso non ha strumenti emotivi maturi per affrontare la situazione e la fuga diventa la scorciatoia più facile.
In conclusione, il “reato di ghosting”, al momento, resta più un tema di dibattito che una realtà giuridica, ma la sua diffusione ci costringe a porci delle domande su come arginare il fenomeno. Forse la risposta non sta (solo) nei tribunali, ma in un cambiamento culturale: imparare che chiudere un rapporto non significa svanire, ma avere il coraggio e il rispetto di dirlo.