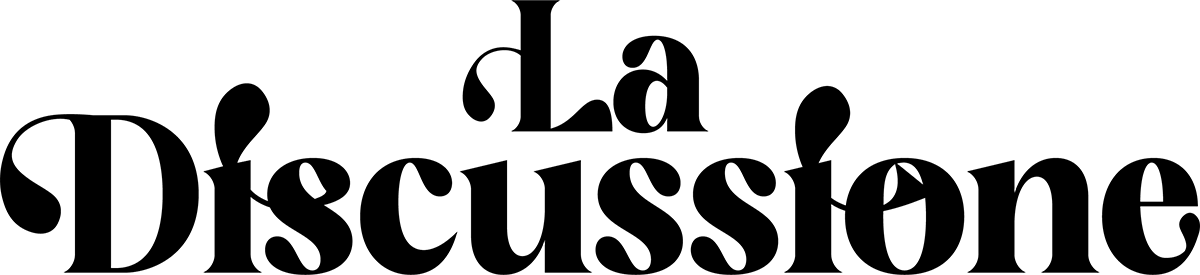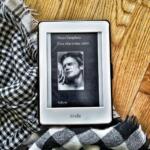Nel 1984 è stata adottata da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione contro la tortura (UNCAT), ratificata da 173 Stati, ma ancora oggi questa pratica disumana resta comunque diffusa a livello globale. Sono 108 i paesi in cui la tortura è un reato, come, ad esempio, in Italia dove è stato introdotto nel Codice penale nel 2017. Ma i Paesi in cui, invece, è ancora praticata sono ben 140: 31 Stati dell’Africa, 11 Stati arabi, 11 Stati dell’Asia/Pacifico, 36 Stati del Consiglio d’Europa su 46 membri, nella Federazione Russa e in 18 Stati del continente americano. La maglia nera sembrerebbe spettare proprio alla Libia, secondo quanto emerge dal Rapporto “Disumani” di Medici Senza Frontiere.
Il Rapporto “Disumani”
Nel 2020 a Palermo Medici Senza Frontiere ha dato vita a un progetto per fornire assistenza sanitaria, psicologica e legale ai migranti e rifugiati sopravvissuti a torture, in collaborazione con l’A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone”, il Dipartimento PROMISE, la CLEDU e l’Università degli Studi di Palermo.
Sono 160 le persone sopravvissute assistite a Palermo tra gennaio 2023 e febbraio 2025, provenienti da 20 Paesi diversi: 15,6% dal Bangladesh, 13,7% dal Gambia, 11% dalla Costa d’Avorio, 9% dal Camerun e un altro 9% dalla Nigeria. L’età media è di 25 anni e il 75% sono uomini mentre il restante 25% donne. Le forme di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, testimoniate dai pazienti presi in esame, avvengono per il 16% nei Paesi d’origine, per l’82% nei Paesi di transito e per il 2% nei Paesi d’arrivo. E il 60% degli episodi è avvenuto in Libia.
In 131 casi è stato riferito che le torture sono state commesse per il 60,3% dai trafficanti e per il 29% da ufficiali delle forze dell’ordine. Molte volte i migranti sono considerate merce e vengono vendute o scambiate tra trafficanti o segregate e utilizzate per estorcere denaro alle famiglie in cambio della loro liberazione. Dal rapporto “Disumani”, nato da questa esperienza sul campo, emerge anche come più del 31% delle vittime abbia subìto percosse, il 15% sottoposto a forme di lavoro forzato, il 5% a prostituzione forzata (tutte donne) e il 6% ha dovuto assistere a forme di violenza e tortura su altre persone. Delle 40 pazienti donne prese in carico, l’80% riferisce di aver subìto una o più violenze sessuali e di genere.
Gli effetti delle torture
Secondo la World Medical Association (WMA) la tortura si può definire come “l’inflizione deliberata, sistematica o indiscriminata di sofferenze fisiche o mentali da parte di una o più persone, agendo da sole o per ordine di un’autorità, al fine di estorcere informazioni, ottenere una confessione o per qualsiasi altro motivo”. Alla base c’è la volontà umana di fare del male e infliggere dolore e si possono definire “tortura di Stato” la detenzione illegittima, la negazione dei bisogni umani fisiologici (acqua, cibo e sonno), la violenza e l’umiliazione sessuale e la violenza fisica e psicologica. In passato, ma in parte ancora oggi, la tortura veniva usata soprattutto in contesti di insicurezza e instabilità politica, mentre attualmente molte delle vittime di tortura sono i migranti della rotta mediterranea, che scappano dal proprio Paese d’origine nella speranza di arrivare in luoghi in grado di dar loro una vita migliore. Durante questi viaggi sono particolarmente vulnerabili e per questo maggiormente esposti a violenze e torture in grado di spezzare il fisico e la mente.
Gli effetti che queste torture e violenze hanno sulle vittime sono molteplici a livello fisico, mentale, culturale e sociale. Inevitabilmente esse maturano sfiducia per l’essere umano e questo fa sì che vivano più isolate, incapaci di costruire relazioni sociali e avere una vita personale e professionale dignitosa. I traumi portano perdita della propria identità, perché il dolore è stato in grado di rompere e modificare il proprio io interiore. Sembra tutto troppo grande, difficile da superare e da accettare. L’auspicio è che i Governi investano maggiormente in assistenza, perché riacquistino una qualche dignità e fiducia nel futuro.