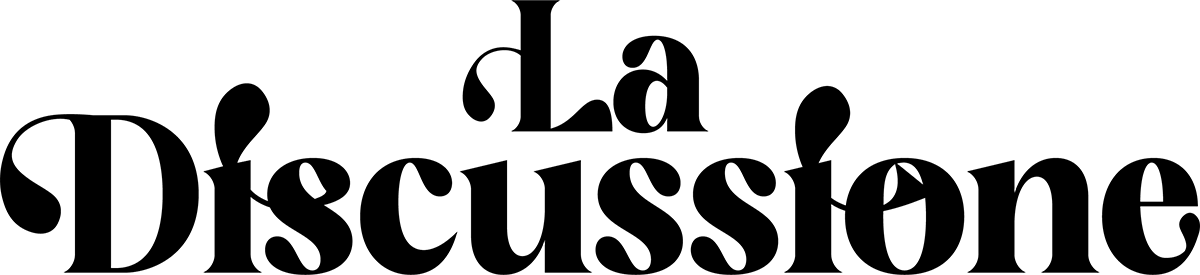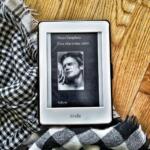Per il grande statista la salvaguardia dei valori comuni era il vero patrimonio da tutelare, nella speranza di una sempre più larga e fraterna solidarietà
Mentre nella Ue si discute di riarmo degli eserciti nazionali e della necessità o meno di una difesa comune spesso viene evocato uno dei Padri dell’Europa e fondatore del nostro giornale, Alcide De Gasperi, che, da Presidente del Consiglio italiano, espresse chiaramente il suo pensiero sull’importanza del progetto della Comunità europea di difesa (CED) nel discorso del 10 dicembre 1951 all’Assemblea del Consiglio d’Europa. Rileggerlo potrebbero aiutare a orientarsi tra le diverse convinzioni, alcune ideologiche, altre meno, tra pacifismo sì pacifismo no, tra più armi o più sanità. Ve ne proponiamo alcuni stralci, che sicuramente meraviglieranno per l’incredibile attualità.
“Desidero anzitutto ringraziare […] dell’invito […] che mi permette oggi di esporre brevemente le mie idee e le mie preoccupazioni a proposito dei gravi problemi cui ci troviamo dinanzi. Malgrado le innumerevoli difficoltà che si sono presentate, il Piano Shuman è sul punto di diventare un fatto compiuto. Io credo che tutti i Paesi qui rappresentati siano ormai d’accordo sul principio che bisogna arrivare ad una forma d’integrazione europea. I pareri differiscono soltanto sul modo di giungervi.[…]
Il bisogno di sicurezza ha creato il Patto Atlantico, cioè un’organizzazione che tende a ristabilire l’equilibrio delle forze. È questa la prima linea di difesa contro il pericolo esterno: essa è basata sull’integrazione dello sforzo nazionale con lo sforzo collettivo. La Comunità atlantica, pur avendo come scopo fondamentale la difesa sul piano militare, mira anche a rafforzare questa solidarietà sopra un piano umano, dove tutti i nostri valori spirituali formano un patrimonio comune e permettono lo sviluppo di una fraternità operante. Ma la condizione essenziale per una resistenza esterna efficace è in Europa. È in Europa la difesa interna contro una funesta eredità di guerre civili – tali bisogna considerare le guerre europee dal punto di vista della storia universale – questo alternarsi, cioè, di aggressioni e rivincite, di spirito egemonico, di avidità di ricchezza e di spazio, di anarchia e di tirannia che ci ha lasciato la nostra storia, per il resto così gloriosa. È dunque contro questi germi di disgregazione e di declino, di reciproca diffidenza e di decomposizione morale, che noi dobbiamo lottare.
Noi siamo consapevoli di doverci salvare e con noi il nostro patrimonio di civiltà comune e di esperienza secolari. Perché se è vero che il Patto Atlantico abbraccia gran parte del mondo, non è men vero che in questo l’Europa custodisce le fonti più antiche e le tradizioni più alte della civiltà. Le somiglianze e le convergenze storiche, nonché i legami spezzati e subito riannodati, ci indicano che la messa in comune delle nostre forze spegne i nostri rancori e può darci in Europa la pace interna, anche prima che un patto di difesa venga a garantirla. L’associazione delle nostre esperienze sociali, culturali, amministrative raddoppia le nostre possibilità nazionali e le preserva da ogni decadenza, dando loro uno slancio nuovo verso la creazione di una civiltà progredita e ancora più elevata.
Quale l’alternativa che si pone per noi, ora, in questo dopoguerra? Noi siamo tutti d’accordo che dobbiamo difendere i nostri focolari, le nostre istituzioni, la nostra civiltà nel momento del pericolo. Ma le nuove generazioni, che tendono a una concezione integrale e dinamica di vita, esitano di fronte ad una scelta che può decidere del loro destino: riprendere la strada interrotta dalla guerra, strada seminata di rivendicazioni e di conflitti che si ispirano ad una concezione etica assoluta della nazione, oppure andare verso queste forze, talora ideali e razionali, tal altra ancora istintive ed irrazionali, in vista di un’espansione superiore e di più larga e fraterna solidarietà.
Quale strada bisogna scegliere per mantenere quello che c’è di umano e di nobile in queste forze nazionali, pur coordinandole verso uno scopo di civiltà supernazionale che possa equilibrarle, riassumerle e comporle in una corrente irresistibile di progresso? Ciò non si può fare se non vivificando le forze nazionali con gli ideali comuni della nostra storia e dando loro come campo di azione le distinte e grandiose esperienze della comune civiltà europea. Non si può fare altrimenti che mediante la realizzazione di un punto d’incontro, dove queste esperienze si confrontano, si selezionano e così governano nuove forme di vita comune, ispirate ad una più grande libertà e ad una più giusta vita sociale. È sopra un’associazione di sovranità nazionali, basata su istituti costituzionali democratici, che queste nuove forme possono espandersi.[…]
La costruzione degli strumenti e dei mezzi tecnici, le soluzioni amministrative sono senza dubbio necessarie: e noi dobbiamo essere grati e coloro che ne assumono il compito. Queste costruzioni formano la armatura: rappresentano ciò che lo scheletro rappresenta per il corpo umano. Ma non corriamo il rischio che si decompongano se un soffio vitale non vi penetri per vivificarle oggi stesso? Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino, si precisino e si animino in una sintesi superiore, non rischieremo che questa attività europea appaia [….] senza calore, senza vita ideale. Potrebbe anche apparire ad un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva quale appare in certi periodi del suo declino il Sacro Romano Impero. In questo caso le nuove generazioni, prese dalla spinta più ardente del loro sangue e della loro terra, guarderebbero alla costruzione europea come ad uno strumento di imbarazzo ed oppressione. In questo caso il pericolo di involuzione è evidente. […]
Se noi chiamiamo le forze armate dei diversi paesi a fondersi insieme in un organismo permanente e costituzionale e, se occorre, a difendere una Patria più vasta, bisogna che questa Patria sia visibile, solida e viva, anche se non tutta la costruzione è perfetta occorre che sin da ora se ne vedano le mura maestre e che una volontà politica comune sia sempre vigilante perché riassuma gli ideali più puri delle nazioni associate e li faccia brillare alla luce di un focolare comune. So bene che questo ideale europeo non è ancora abbastanza radicato nelle folle: non c’è che una parte di uomini politici, pensatori ed idealisti, i quali riescano a sottrarsi alla cura quotidiana dei problemi della ricostruzione dei loro paesi per rivolgere i propri sforzi alla preparazione di un avvenire comune.[…]
Ora, benché in Italia questa idea debba fare ancora strada e debba essere oggetto di approfonditi dibattiti in Parlamento, oso qui innanzi a voi esprimere la speranza che, conformemente allo spirito della Costituzione, la nazione italiana, se pur uscita spoglia dalla guerra, sarà disposta ad accettare dei limiti ragionevoli alla sua sovranità nazionale, in unione con le altre nazioni europee, se ciò può servire ad allargare il campo del suo slancio vitale.[…]
Si presenta ora il problema dell’esercito europeo, problema, come ho detto, delicato, che tocca le stesse fibre più intime dell’organismo nazionale, io non posso esprimere qui in questo momento che il mio personale avviso: ma credo che il Parlamento italiano non rifiuterà il suo assenso al meritorio sforzo di uomini generosi ed antiveggenti per creare uno stabile ponte fra nazioni, separate spesso nel passato da un abisso nel quale precipitò tutta l’Europa. L’approvazione non mancherà, se questo ponte sarà solidamente gettato ed appoggiato sui pilastri del sentimento popolare, e costituirà veramente il vincolo fra nazioni libere ed eguali.
Per creare questo ponte è dunque evidente che il primo, il principale pilastro dev’essere rappresentato da un Corpo eletto comune e deliberate, anche con attribuzioni di decisioni e di controllo limitato a ciò che è amministrato in comune, e dal quale dipenda un organismo esecutivo collegiale. Il secondo pilastro sarebbe costituito da un bilancio comune che tragga le sue entrate da contributi individuali, cioè dal sistema di tassazione. La storia ci insegna che la forma di contribuzione degli Stati, come sistema esclusivo per sopportare spese comuni, può provocare pericolose divergenze e contenere germi di dissoluzione. Non è poi così difficile per ciascun Stato devolvere il prodotto di un monopolio o di una imposta di altra natura a profitto del bilancio comune. Questo sistema mi sembra costituire un minimo necessario perché il progetto ottenga l’approvazione dei Parlamenti e il consenso delle popolazioni. Quando questo esercito, così organizzato ed amministrato, sarà inserito nella NATO secondo le risoluzioni della Conferenza di Roma, noi avremo raggiunto l’unione di tutte le forze difensive e nel medesimo tempo avremo creato all’interno un nucleo federale europeo che sarà la garanzia della nostra solidarietà democratica.
È vero che ognuno di noi ha nel suo Paese problemi che lo incalzano da tutti i lati, è vero che alcuni potrebbero desiderare di perseguire quest’opera di coordinazione in altri settori più facili, ma ciascuno sente che questa è l’occasione che passa e non tornerà più. Bisogna afferrarla ed inserirla nella logica della storia. Dopo aver dunque reso omaggio agli uomini coraggiosi che hanno iniziato questa opera e l’hanno fatta progredire, io penso che sia tempo ora di esortarci tutti a compierla. È assolutamente necessario che il nostro compito non fallisca, e che trovi nei Paesi la collaborazione di tutte le forze democratiche e di rinnovamento sociale, e ridia nello stesso tempo in tutti i nostri amici, particolarmente in America, la fede nei destini dell’Europa”.