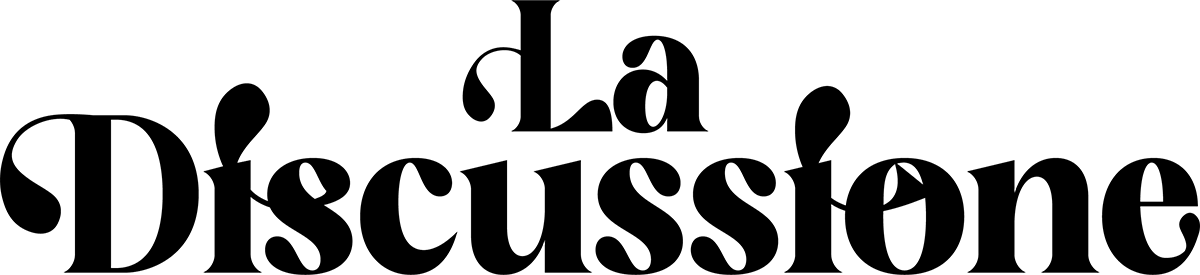Dopo il greenwashing, o ecologismo di facciata, quella strategia di marketing ingannevole utilizzata dalle aziende per costruire un’immagine ecologicamente sostenibile, spesso falsa, al fine di distogliere l’attenzione da impatti ambientali negativi, ecco che arriva il pinkwashing, una altra strategia di marketing che utilizza simboli, temi e linguaggi legati alla causa della parità di genere e all’emancipazione femminile per promuovere prodotti, servizi o migliorare l’immagine pubblica di un’azienda, senza un reale impegno concreto verso queste cause, mascherando pratiche negative o sfruttando la sensibilità del pubblico per aumentare vendite e reputazione.
Negli ultimi anni il femminismo è entrato con forza nel linguaggio della comunicazione commerciale. Slogan sull’empowerment femminile, campagne contro il sessismo, packaging rosa con messaggi di inclusione mostrano un mercato apparentemente vicino alla causa delle donne. Ma dietro questa millantata alleanza tra attivismo e branding si nasconde spesso un’operazione ambigua.
Che cos’è il pinkwashing
Il termine indica l’uso strumentale dei valori femministi da parte di aziende e istituzioni per migliorare la propria immagine o aumentare le vendite. Una strategia che, invece di scardinare le disuguaglianze, rischia di rafforzarle, trasformando una lotta politica e sociale in un semplice stile comunicativo. Queste campagne sono ovunque: magliette con scritte come “Girl Power”, spot che celebrano la “forza delle donne”, cosmetici che promettono libertà e autodeterminazione. Messaggi potenti, ma spesso svuotati di contenuto. Non è raro che gli stessi marchi che si proclamano femministi paghino le lavoratrici meno dei colleghi uomini, sfruttino manodopera femminile nei Paesi a basso reddito o mantengano consigli di amministrazione quasi esclusivamente maschili.
Quando l’attivismo diventa una merce
Il problema non è la presenza del femminismo nel discorso pubblico, ma la sua riduzione a prodotto. Quando l’uguaglianza diventa un hashtag e la liberazione un claim pubblicitario, il rischio è quello di confondere il consumo con il cambiamento. Comprare un prodotto “femminista” può dare l’illusione di un impegno etico, senza mettere in discussione strutture economiche e sociali profondamente diseguali.
Il pinkwashing funziona perché intercetta una domanda reale. Molte persone, soprattutto giovani, chiedono coerenza, inclusività e responsabilità sociale. Il marketing risponde adattandosi, ma spesso solo in superficie. Il risultato è un femminismo addomesticato, compatibile con il profitto, che evita i temi più scomodi come la redistribuzione del potere, i diritti riproduttivi, la violenza di genere o la precarietà del lavoro.
La studiosa Sarah Banet-Weiser, nel suo libro Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny, sottolinea come il femminismo contemporaneo sia spesso “reso sicuro” per il mercato, cioè visibile, ma depoliticizzato. Le aziende celebrano la forza delle donne negli spot, mentre mantengono disuguaglianze salariali, leadership maschili e filiere produttive poco etiche. Il risultato è un femminismo “brandizzato”, facilmente consumabile, ma privo di conflitto.
Questa dinamica è evidente anche nel modo in cui il corpo femminile continua a essere centrale nella pubblicità. Come osservava Angela McRobbie, il postfemminismo non elimina il controllo sul corpo delle donne, ma lo trasforma: non più imposizione esterna, bensì auto-sorveglianza volontaria. Anche quando il corpo è celebrato nella sua diversità, resta il principale terreno su cui si misura il valore femminile.
Il femvertising e il nuovo linguaggio dell’empowerment
Parole come empowerment, inclusività, body positivity sono, dunque, entrate stabilmente nel vocabolario del marketing. Ma è lecito chiedersi se questo cambiamento sia sempre autentico o se ci troviamo di fronte a una nuova forma di appropriazione simbolica delle istanze femministe.
A confondere le acque contribuisce anche il femvertising, che nasce dall’unione di feminism e advertising e che indica quelle campagne pubblicitarie che sfidano gli stereotipi di genere, promuovendo una rappresentazione più autonoma, plurale e realistica delle donne. Si tratta di una pubblicità che mette in discussione i cliché tradizionali, celebra la forza e l’indipendenza femminile e valorizza la diversità dei corpi, delle età e delle identità.
Campagne come Bellezza autentica della Dove o #LikeAGirl della Always sono diventate emblematiche di questo approccio. Mostrano donne comuni, ridefiniscono il linguaggio della fragilità e provano a trasformare l’insicurezza in autostima.
Ma, secondo la sociologa Rosalind Gill molte di queste rappresentazioni rientrano in ciò che lei definisce postfeminist media culture, una cultura in cui il femminismo non viene negato, ma assorbito e neutralizzato. L’empowerment diventa una responsabilità individuale, non una questione politica o collettiva. La donna è “libera”, purché continui a lavorare su se stessa, sul proprio corpo e sulla propria immagine. Come scrive Gill, il messaggio implicito è che “la disuguaglianza non è più strutturale, ma una questione di scelta personale”. In questo modo, la pubblicità può parlare di libertà femminile senza mai mettere in discussione i rapporti di potere che la producono.
Non tutte le campagne sono uguali
E’ giusto però dire che non tutte le iniziative che parlano di donne sono automaticamente pinkwashing. Alcune aziende stanno provando ad adottare politiche più eque, agendo sulla trasparenza salariale, i congedi parentali paritari, gli investimenti concreti contro la violenza di genere. La distinzione sta nella coerenza tra messaggio e pratica.
Per consumatori e consumatrici la sfida è sviluppare uno sguardo critico, chiedersi chi produce, come e a quali condizioni. Andare oltre lo slogan e osservare i fatti. Perché se è vero che la visibilità conta, è altrettanto vero che senza un impegno reale il rischio è quello di svuotare una battaglia storica, trasformandola in un accessorio stagionale. In altre parole il femminismo non ha bisogno di essere venduto per esistere, quanto piuttosto di essere praticato.
Leggi anche: