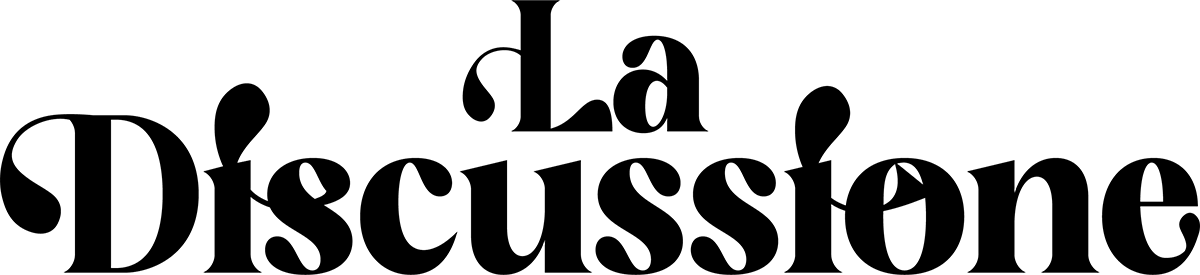Esiste una caratteristica che accomuna in modo sorprendentemente positivo Millennial e Gen Z: una maggiore attenzione alla salute mentale e una crescente disponibilità a chiedere aiuto a figure professionali adeguate, non solo per sé, ma anche per chi sta intorno. Un cambiamento generazionale rilevante, soprattutto se confrontato con l’atteggiamento tipico dei boomer, spesso riassumibile nella frase “dallo psicologo ci vanno i pazzi” o nella negazione di problematiche anche gravi e disfunzionali.
Questa spinta verso il miglioramento personale delle generazioni più giovani è sicuramente legata anche allo sviluppo dei social come spazi di divulgazione psicologica. Profili Instagram e TikTok che parlano di salute mentale offrono spunti importanti, che per qualcuno rappresentano addirittura un primo campanello d’allarme che li spinge a chiedere aiuto. Tuttavia, questi contenuti possono trasformarsi facilmente in un’arma a doppio taglio.
Video, post e caroselli diventano spesso uno specchio emotivo, raccontano sintomi, elencano comportamenti, suggeriscono interpretazioni. Il rischio emerge quando ci si autodiagnostica una psicopatologia senza le competenze necessarie, sicuri di riconoscere in se’ un sintomo che non per forza ha una corrispondenza clinica. Si può essere stanchi senza essere in “burnout”, si può avere momenti di egocentrismo senza essere necessariamente “narcisisti” e si può essere distratti senza essere “ADHD”, cioè senza un deficit dell’attenzione. “Questo linguaggio offre strumenti per raccontarsi – spiega al nostro giornale la psicologa Chiara Ballone –ma allo stesso tempo semplifica concetti molto complessi. Parole come trauma, narcisismo tossico o altri di uso comune possono offrire un vocabolario per descrivere le proprie esperienze emotive, ma c’è il rischio che diventino strumenti manipolatori o etichette superficiali”.
Therapy Speak: il linguaggio della salute mentale sui social
Quando la semplificazione diventa eccessiva il rischio è duplice: si etichettano gli altri con leggerezza e, ancora più rapidamente, si etichetta se stessi. A quel punto, il passo verso la diagnosi fai-da-te è breve. Sempre più pazienti, racconta la Ballone, non arrivano in terapia con un disagio da esplorare, ma con un’etichetta da confermare. “La terapia – suggerisce l’esperta – dovrebbe essere un viaggio di scoperta. Invece rischia di diventare una caccia ai sintomi”.
In questo processo si perde qualcosa di fondamentale come la storia personale, il contesto, le sfumature, perché “due persone possono avere gli stessi sintomi ma vivere esperienze completamente diverse”, sottolinea Ballone. Sui social questo non emerge, i contenuti funzionano per somiglianza, non per complessità.
Questa confusione non rappresenta solo un problema clinico, ma anche culturale, definito dallo psichiatra Allen Frances “medicalizzazione della normalità”. Il lutto, la timidezza, la fatica di crescere o di invecchiare rischiano di essere trasformati in patologie. “Il paradosso – osserva Ballone – è una società in cui siamo tutti malati. E se siamo tutti malati, nessuno lo è davvero”.
Dare senso al disagio o banalizzare la sofferenza
Alla domanda se le “diagnosi social” aiutino a riconoscere un disagio oppure rischino di cristallizzarne uno la specialista riconosce una doppia dimensione: “Da un lato legittima il dolore e rompe l’isolamento, dall’altro rischia di banalizzare la sofferenza grave” .
Quando termini clinici diventano metafore di uso quotidiano, si crea una gerarchia tossica della sofferenza, in cui l’etichetta diagnostica assume lo status di identità. “Il rischio è confondere un trauma significativo con un disagio passeggero”. In questo modo, il dolore profondo perde specificità e quello lieve viene patologizzato.
Esiste, poi, un aspetto più strutturale legato alla individualizzazione del malessere. Secondo la psicoterapeuta “problemi sociali, lavorativi o familiari vengono trasformati in vere e proprie patologie personali da curare”. Dinamiche tossiche o relazioni di potere sbilanciate diventano sintomi individuali, spesso medicalizzati, invece di essere riconosciuti come problemi collettivi.
Diagnosi come identità o come strumento
Una distinzione cruciale riguarda il peso dell’etichetta diagnostica. Quando, cioè, la diagnosi diventa un’identità, si trasforma nel centro della narrazione di sé. Espressioni come “sono borderline” o “sono ADHD” non descrivono più un’esperienza, ma definiscono l’intera persona. In questi casi, il disturbo può trasformarsi in uno scudo, una giustificazione che riduce il senso di responsabilità e la possibilità di cambiamento. Al contrario, quando l’etichetta viene utilizzata come strumento di comprensione, diventa un punto di partenza. Il lavoro terapeutico consiste proprio nello spostarsi dal “questo sono io” al “questo è un aspetto di ciò che sto vivendo”.
Algoritmi, confronto sociale e autostigmatizzazione
La viralità dei contenuti psicologici, dunque, produce effetti collaterali sul benessere mentale. “Viviamo in una bolla algoritmica” dice Ballone, i social amplificano convinzioni preesistenti e favoriscono un monitoraggio ipervigile di sé. Emozioni comuni e frustrazioni quotidiane vengono lette come segnali di patologia e il confronto sociale accentua ulteriormente il problema. Vedere che persone con una medesima “diagnosi” hanno successo può generare vissuti di fallimento e autostigmatizzazione. Per la dottoressa “la diagnosi diventa una gabbia, una profezia che si autoavvera, limitando aspettative e possibilità percepite”.
Il ruolo dello psicologo nell’era dei social
In questo scenario il compito dello psicologo non è negare il linguaggio dei social, ma accoglierlo e decostruirlo. “È necessario partire dal linguaggio del paziente e poi scomporre l’etichetta, esplorare la funzione del sintomo, la storia personale, il contesto relazionale e sociale”.
Fondamentale è anche educare al pensiero critico, spiegare come funzionano gli algoritmi, come si crea una camera dell’eco e come certi contenuti diventano virali. Non per demonizzare i social, ma per restituire complessità ai fenomeni.