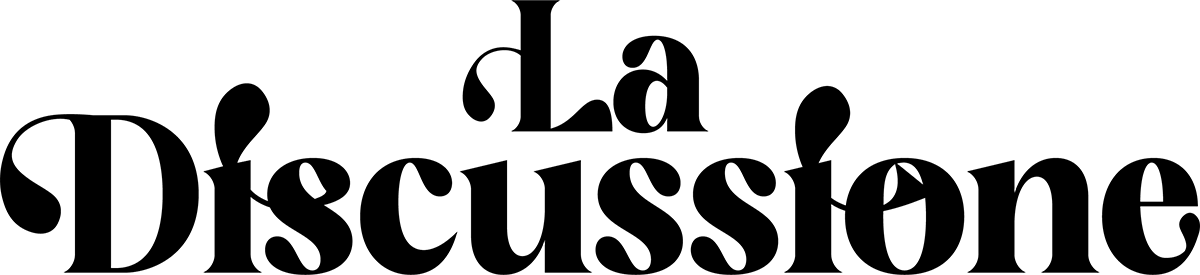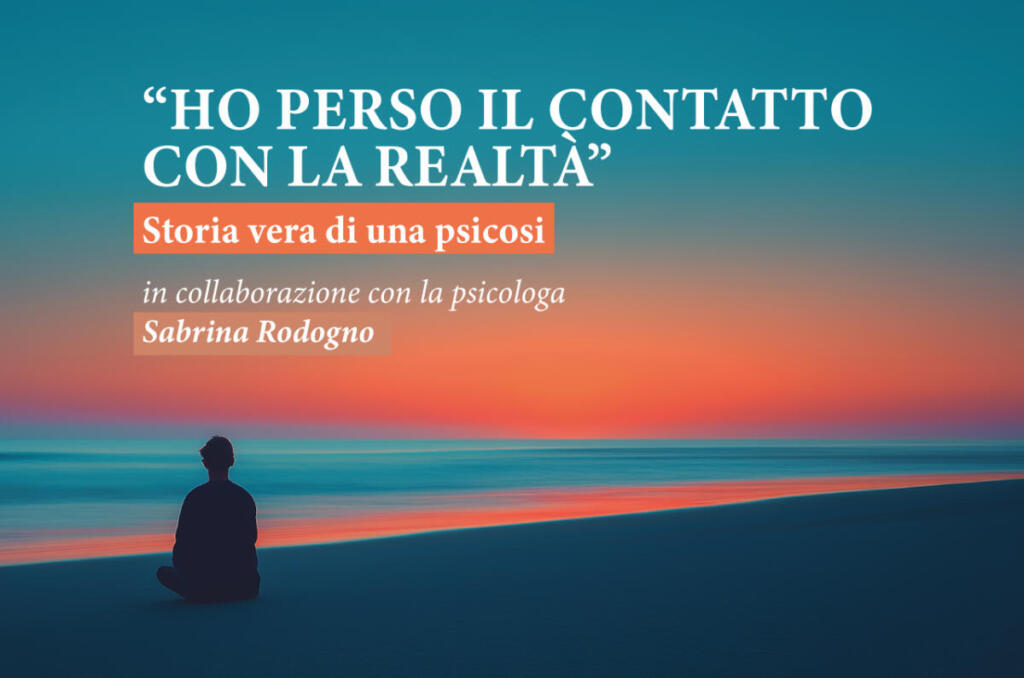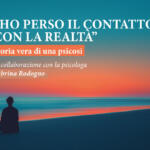A livello medico si chiama disturbo depressivo maggiore, ed è uno dei problemi di salute pubblica più rilevanti del nostro tempo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce in un dato momento circa il 5% della popolazione mondiale, con una distribuzione doppia nelle donne rispetto agli uomini. Ma questi numeri non bastano a descrivere cosa succede davvero: perché la depressione non è “solo” un umore basso, è una condizione che cambia il modo in cui il cervello funziona e comunica con il resto del corpo.

Per decenni la spiegazione dominante è stata quella “monoaminergica”: la depressione come conseguenza di una carenza di tre neurotrasmettitori chiave – serotonina, noradrenalina e dopamina – responsabili rispettivamente della regolazione dell’umore, dell’energia e della motivazione. Questa teoria ha portato allo sviluppo dei principali antidepressivi ancora oggi in uso, come gli SSRI.
Ma non sono l’unica opzione: in base al profilo del paziente, lo psichiatra può valutare altre molecole come la venlafaxina o la duloxetina (che agiscono anche sulla noradrenalina) o il bupropione, che stimola la dopamina e la noradrenalina ed è particolarmente indicato nei casi con forte componente di anedonia e stanchezza marcata, con l’ulteriore vantaggio che, a differenza di molti SSRI, tende a non interferire con la sfera sessuale.
La ricerca degli ultimi vent’anni ha complicato il quadro. Oggi sappiamo che nella depressione giocano un ruolo anche il glutammato, principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello, e la neuroplasticità, cioè la capacità dei neuroni di creare nuove connessioni. Quando questa capacità diminuisce – anche per colpa di stress prolungato o livelli eccessivi di cortisolo – alcune aree come l’ippocampo si riducono di volume, rendendo più difficile regolare emozioni e memoria.
C’è poi la questione dell’infiammazione. Diversi studi hanno trovato nei pazienti depressi livelli più alti di citochine pro-infiammatorie, molecole che il sistema immunitario produce in risposta a infezioni o stress. È come se il corpo vivesse in uno stato di allerta costante, e questa allerta si riversasse nel cervello, alterando la trasmissione chimica e l’equilibrio emotivo. Questa prospettiva “immuno-psichiatrica” spiega anche perchéattività come l’esercizio fisico o una dieta anti-infiammatoria possano avere un effetto positivo sull’umore.
La depressione non ha un solo volto. Può presentarsi in forme gravi e improvvise, o strisciare per anni a bassa intensità, come nella distimia. Può essere unipolare o parte di un disturbo bipolare. Può avere un andamento stagionale, e non sempre questo significa peggiorare in inverno. Esiste infatti una forma meno conosciuta: la depressione stagionale estiva.
Chi ne soffre spesso vede peggiorare i sintomi proprio quando “dovrebbe” sentirsi meglio: con più luce, più tempo libero, più occasioni sociali. Invece compaiono insonnia, perdita di appetito, irritabilità e una strana sensazione di calore interno. Le cause non sono del tutto chiare, ma gli studiosi ipotizzano che un’eccessiva esposizione alla luce possa alterare i ritmi circadiani, riducendo la produzione di melatonina e disturbando pertanto il sonno. Le alte temperature possono aggiungere stress fisiologico, e l’“obbligo” sociale di essere felici in estate può amplificare la percezione di inadeguatezza.
Il rischio più grande della depressione – in tutte le sue forme – è che venga sottovalutata. Più a lungo resta senza trattamento, piùsi radica nei circuiti cerebrali, diventando resistente alle cure. Il suicidio è una delle sue conseguenze più estreme: chi ha un disturbo depressivo maggiore ha un rischio venti volte più altorispetto alla popolazione generale.
Il trattamento oggi è più vario che in passato. Farmaci e psicoterapia restano le opzioni più consolidate, ma la ricerca sta esplorando terapie di neuromodulazione come la stimolazione magnetica transcranica e l’uso controllato di ketamina. L’idea è affrontare la depressione come una malattia sistemica, che coinvolge cervello, corpo e ambiente.
Parlarne con precisione scientifica, ma anche con comprensione umana, serve a smontare il pregiudizio che la depressione sia solo “una questione di volontà”. Non lo è. È una condizione biologica complessa, che si può curare, e che merita di essere capita fino in fondo – in inverno come in piena estate.
Noi ne parliamo ogni settimana su Mind, la salute mentale senza censure.