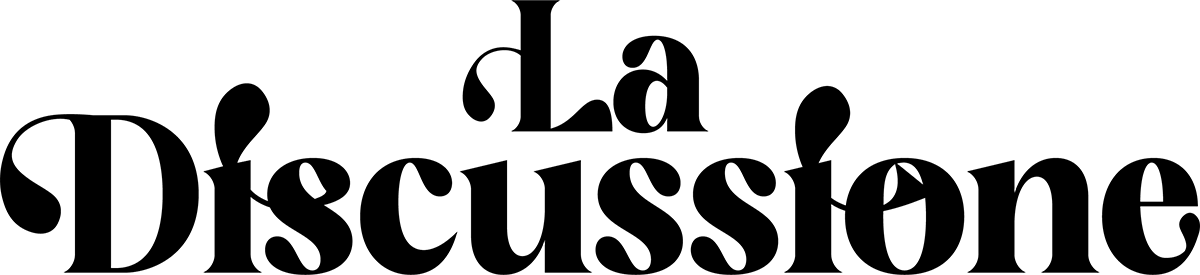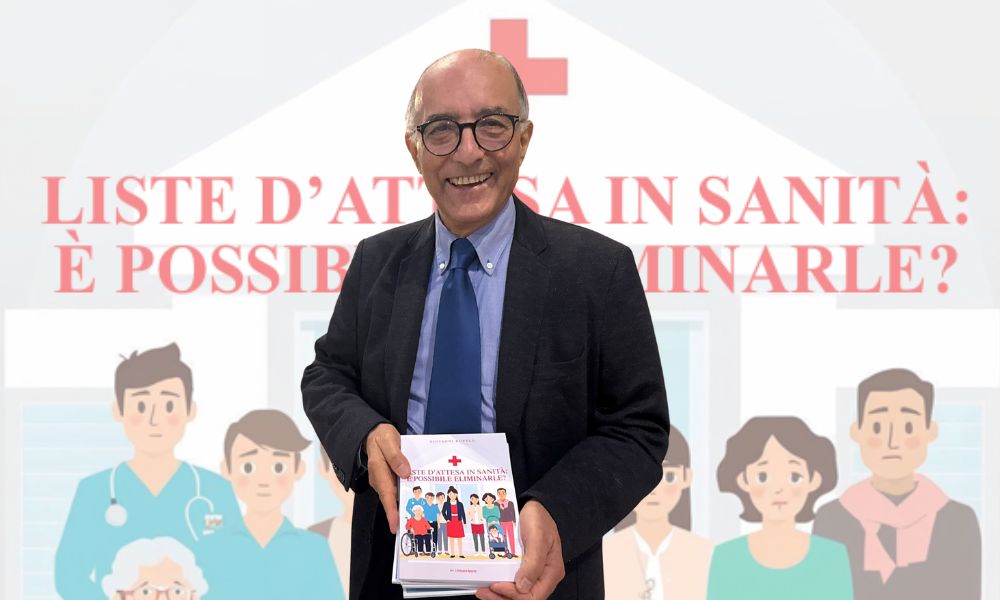C’è un’Italia che vive dietro le sbarre, che spesso rimane invisibile.
È l’Italia degli oltre 62 mila detenuti, delle donne recluse in sezioni improvvisate, dei minori senza futuro e degli agenti stremati. Un’Italia che Il silenzio dentro (Swanbook Edizioni, ottobre 2025) di Francesca Ghezzani — giornalista, autrice e tra i soci fondatori dell’Associazione Constructive Network APS — riporta al centro del dibattito civile.

Un libro di inchiesta e di ascolto, che unisce dati, voci, storie e analisi per mostrare ciò che spesso resta fuori dalle cronache: il carcere come specchio della società. Ghezzani, con il rigore del giornalismo costruttivo, affronta il tema da dentro: varca i cancelli, incontra detenuti, direttori, magistrati, criminologi e volontari. Ne esce un quadro duro ma necessario. «Il carcere — spiega — non è un altrove: è parte della nostra comunità. E se non funziona, a perdere siamo tutti».
Il titolo del suo libro, “Il silenzio dentro”, sembra un ossimoro. Di quale silenzio parla?
Del silenzio frequente delle istituzioni e dell’opinione pubblica. È il silenzio che avvolge un mondo dove le persone sembrano sparire. Ma è anche il silenzio interiore di chi cerca davvero una seconda possibilità e non trova ascolto.
Nel libro lei intreccia giornalismo e giustizia. Qual è il confine?
Il giornalismo, se vuole essere servizio pubblico, non può fermarsi alla cronaca nera o alla condanna. Deve chiedersi se un sistema rieduca, quali soluzioni sono possibili. Raccontare diventa così un atto di giustizia civile.
Lei parla spesso di “giornalismo costruttivo”. In cosa si differenzia da quello tradizionale?
Non significa essere indulgenti, ma andare oltre la denuncia sterile. Il giornalismo costruttivo racconta anche chi prova a cambiare le cose. È un approccio che unisce verità e responsabilità.
I dati sulle carceri italiane restano drammatici. Da dove ripartire?
Dal rispetto dell’articolo 27 della Costituzione: la pena deve tendere alla rieducazione. Questo implica investire su formazione, salute mentale, lavoro e personale. Oggi, invece, stando a quanto emerso dalle interviste contenute nel libro, il carcere è molte volte un luogo che produce recidiva e disperazione.
Che ruolo ha la politica in tutto questo?
Un ruolo enorme, da sempre e a prescindere da chi in quel dato momento si trova al governo o all’opposizione. La politica deve occuparsi di giustizia penitenziaria non come emergenza, ma come priorità civile.
In un’epoca dominata dai social e dal giudizio immediato, quanto è difficile restituire complessità? È difficilissimo, ma necessario. La semplificazione alimenta paura e populismo penale. Ascoltare le storie, i numeri e le persone è l’unico antidoto per difendere la democrazia dal moralismo, dall’indifferenza e ridare sicurezza alla collettività.