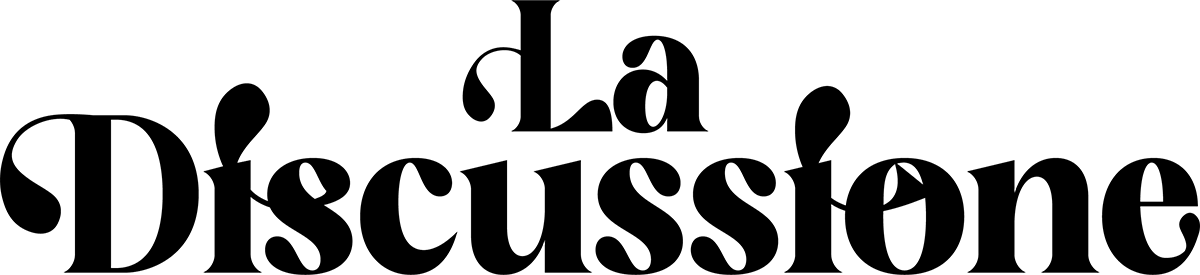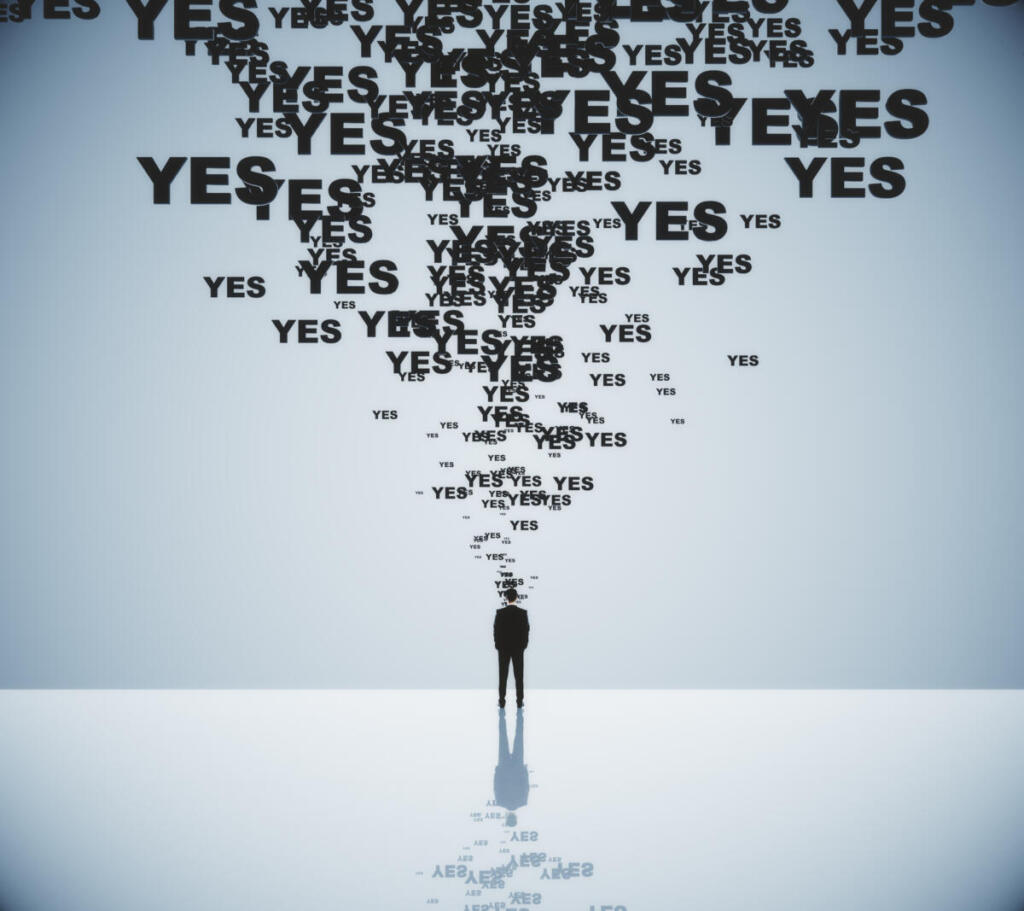Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, recita il proverbio. Ma se a piacere è il brutto nella sua oggettività e questo diventa moda, allora forse dietro c’è lo zampino di qualche genio del marketing. Da tempo assistiamo a un fenomeno che esalta il trasandato, lo sguaiato, lo sciatto. Uno stile che, inizialmente, apparteneva a piccole nicchie di outsider in cerca di autenticità, in opposizione ai canoni di perfezione imposti dalla società capitalistica, ma che oggi sembra essere il trend dominante. Non a caso Meryl Streep, nell’iconico film “Il diavolo veste Prada”, ci ricordava quanto anche il nostro gusto personale, persino nelle scelte anticonvenzionali, sia spesso guidato da chi la moda la crea e la decide.
Un tempo, la bellezza o la bruttezza di un capo, al di là della moda del momento, restava opinabile, basti confrontare due generazioni diverse. Oggi, però, molte case di moda e brand di abbigliamento hanno scelto volontariamente di fare del brutto la propria identità.
La moda “ugly” chic: una sfida ai canoni classici di bellezza e raffinatezza
Non è un caso se Balenciaga, Vetements, Margiela, Crocs o Rick Owens siano diventati i portabandiera di questo stile sproporzionato, oversize, dai colori cupi, spesso strappato o volutamente sgraziato, in cui anche i capi più semplici vengono venduti a peso d’oro. Una felpa può anche superare i mille euro.
Questi brand hanno capito che, in un mercato saturo di pezzi “aesthetic”, il brutto rompe gli schemi e conquista una fetta di consumatori desiderosi di distinguersi, sentirsi alternativi, ma senza rinunciare allo status. Da qui combinazioni cromatiche “sbagliate” e silhouette che sfidano ogni regola di proporzione. È un’estetica che, dietro la sua aria casuale, è invece attentamente studiata. Le passerelle si trasformano così in palcoscenici dove l’anti-bello diventa spettacolo e allo stesso tempo provocazione e dove il capo “brutto” è in realtà il nuovo lusso da ostentare.
Il caso “brat”, simbolo di ribellione e indipendenza
Il brat è un fenomeno culturale esploso nel 2024 dopo l’album omonimo della cantante Charli XCX. In breve tempo si è esteso in vari ambiti, proponendo un’estetica trasandata che mixa colori fluo, come l’iconico verde, elementi minimal, dettagli grezzi, tocchi sexy e influenze anni ’90/2000. Il tutto con un’attitudine ribelle, schietta, sarcastica.
Sui social, un tempo invasi da profili patinati e perfetti, oggi convivono gallerie di foto sfocate, scatti “no sense” e outfit volutamente discutibili. L’idea è chiara: la vera sensualità sta nel non curarsi del giudizio altrui, in modo disinvolto e ironico.
La forza del brat sta nella sua capacità di rendere il disordine un codice riconoscibile, quasi un “passaporto” estetico per chi vuole sentirsi parte di una community. È una ribellione giocosa, che utilizza il kitsch, il trash e l’ironia come armi di identità, trasformando ogni imperfezione in dichiarazione di stile.
Brutto, ma strategico
In estrema sintesi, la differenza principale tra moda “brat” e moda “ugly” risiede nel loro approccio estetico e nel messaggio che veicolano. La moda “brat” si concentra su un’immagine ribelle, eccentrica e a volte provocatoria, mentre la moda “ugly” abbraccia capi e combinazioni che potrebbero essere considerate esteticamente poco gradevoli o fuori dagli schemi, spesso con l’intento di sfidare le convenzioni di bellezza tradizionali. Ma la verità è che non c’è nulla di davvero nuovo. Il ricorso a ciò che rompe i canoni per differenziarsi è una strategia consolidata, presente anche nella pubblicità. Ne sono un esempio gli spot volutamente goffi di Old Spice o Squatty Potty, che puntano su immagini grottesche e “brutte” per catalizzare l’attenzione e diventare virali. Oppure alla campagna “Moldy Whopper” di Burger King (2020), che mostrava un panino coprirsi di muffa in time-lapse per comunicare l’assenza di conservanti artificiali, una scelta visiva radicale in un settore che da sempre evita immagini di cibo deteriorato.
Lo stesso meccanismo si ritrova nelle pubblicità di Diesel con lo slogan “Be Stupid”, che celebravano situazioni assurde e imperfette come segno di autenticità. O negli spot di Benetton firmati da Oliviero Toscani, che hanno sconcertato il pubblico con immagini crude e disturbanti per lanciare messaggi sociali.
Anche Ikea ha sfruttato questo filone con campagne come quella che mostrava camere disordinate o oggetti usurati in totale contrapposizione con l’idea di perfezione da catalogo. I brandi beauty Glossier e Fenty Beauty hanno scelto, in alcune campagne, foto naturali con evidenza di difetti e pelle imperfetta, volutamente non ritoccate, sfidando il proprio settore, da sempre portavoce di una bellezza artificiosa .
Quando l’anticonvenzionale diventa integrazione
Il brutto, dunque è una scelta consapevole. Funziona perché provoca, attira, divide. Nel momento in cui diventa tendenza, smette di essere ciò per cui era stato scelto. Non più un atto di ribellione, ma qualcosa di codificato, vendibile. E l’ingenuo consumatore, pensando di fare una scelta fuori dagli schemi, finisce spesso in una neanche troppo ben celata trappola di omologazione. Anche in questo caso profetico il famoso monologo del maglioncino ceruleo ne “Il diavolo veste Prada” .
È il paradosso della moda: per essere davvero diverso, a volte devi assomigliare agli altri che vogliono essere diversi. Il risultato? Un mercato che ride sotto i baffi mentre incassa.