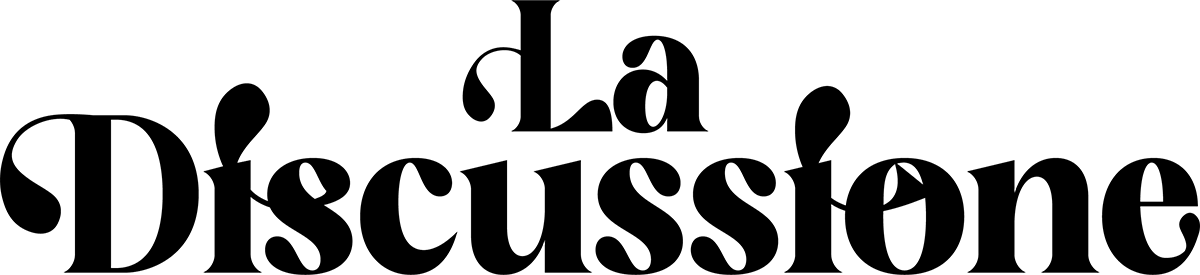Tra Guerra fredda, narrazioni mediatiche e diffidenze reciproche la comprensione tra Italia e Cina resta fragile. Per questo il percorso di Bian Qian, arrivata nel 2007, racconta molto più di una semplice storia di integrazione. È diventata una delle voci più attente nel far conoscere la Cina agli italiani, tra identità, tradizione e malintesi condivisi. In una intervista ci spiega perché la Cina non si può leggere con categorie occidentali.
Prima di parlare dei fraintendimenti culturali reciproci, tra italiani e cinesi, puoi raccontarci il tuo percorso dal tuo arrivo in Italia alla scelta di dedicarti alla divulgazione della cultura cinese? Chi è Kina?
Mi chiamo Bian Qian. Il mio nome è Qian, ma iniziando con la lettera Q è piuttosto difficile da pronunciare per gli italiani. Per questo, con gli amici italiani, mi presento quasi sempre con il cognome, Bian. Poi magari, dopo due o tre anni di amicizia, capita che qualcuno scopra per caso di avermi chiamata per cognome per tutto quel tempo. Diciamo, quindi, che Bian, che in realtà è il mio cognome, è diventato il mio nome italiano.
Non sono come la maggior parte dei ragazzi cinesi che si vedono sui social, spesso di seconda o terza generazione, con genitori che lavorano o fanno affari in Italia. Io sono arrivata nel 2007, quasi per caso, grazie a un programma di scambio tra la mia università in Cina, dove studiavo giornalismo a Nanchino, e il Politecnico di Torino. Lo scambio si inseriva in un più ampio processo di internazionalizzazione delle università italiane, soprattutto verso la Cina. In quegli anni stava crescendo anche in Italia un nuovo interesse per la Cina e per il mercato cinese e di conseguenza gli scambi culturali e istituzionali erano diventati molto più frequenti.
In un certo senso, io sono il prodotto di quegli scambi. Sono venuta in Italia per studiare e, una volta terminata la mia formazione in giornalismo, ho iniziato a lavorare. Durante il periodo del Covid, però, mi sono resa conto che c’era ancora molto lavoro da fare sulla comprensione della Cina da parte del pubblico italiano: la Cina come Stato, come potere, come popolo, ma anche come lingua, che è davvero molto diversa dall’italiano.
In quel periodo sono emersi tanti malintesi, a volte veri e propri pregiudizi o episodi di razzismo. Ho sentito il bisogno di fare qualcosa, per me stessa, per i miei figli, che hanno un background misto, per il mio Paese e anche per la comunità cinese in Italia, che purtroppo è spesso percepita come chiusa, con la tendenza a interagire soprattutto al proprio interno.
Così ho deciso di avviare questa attività di divulgazione, basata sulla mia esperienza e sulla mia formazione. Essendo nata e cresciuta in Cina e avendo ricevuto lì tutta la mia educazione, conosco bene la cultura del mio Paese. Ho sentito che era una cosa necessaria e significativa, non solo per me, ma per molti cinesi. Credo anche che questo sia il momento giusto per aprire quell’orizzonte.
Nei tuoi video torni spesso su elementi centrali della tradizione culturale cinese, dalla filosofia alla scrittura, fino ai modelli di organizzazione del potere. Perché questi aspetti sono ancora decisivi per comprendere la Cina contemporanea?
È una bellissima domanda. Oggi l’idea di “tradizione” culturale viene spesso percepita come qualcosa di vecchio, poco efficace, non più adatto al presente. Alle persone piace sentirsi dentro un mondo nuovo, evoluto, pensare di vivere qualcosa di inedito nel proprio contesto storico. Per i cinesi, però, questo non funziona allo stesso modo. Siamo uno dei pochi casi in cui una civiltà antica è rimasta viva e continua a sopravvivere. Per questo la tradizione, per noi, non è qualcosa di remoto o superato. È qualcosa di utile, necessario per sopravvivere.
E non intendo “sopravvivere” nel senso di diventare potenti o egemoni, né di sentirsi culturalmente superiori. Il nostro rapporto con la tradizione è molto pragmatico. Non si tratta nemmeno di sopravvivere per qualche anno o per un paio di secoli, ma di preservare un’identità culturale lungo millenni.
Posso fare due esempi concreti. Il primo riguarda la scrittura. In Occidente si parla spesso di ideogrammi, ma io preferisco chiamarli caratteri. I caratteri cinesi sono stati formalizzati circa duemila anni fa e, da allora, non sono cambiati in modo sostanziale. Questa continuità ha permesso alla nostra cultura di rimanere connessa al proprio passato. Dal punto di vista linguistico e scritto, dopo duemila anni possiamo ancora leggere e comprendere testi antichi. Questa continuità della lingua significa anche continuità del pensiero. Non c’è una frattura radicale tra il passato e il presente.
Il secondo esempio è il confucianesimo. Non è soltanto un insieme di regole sociali o di indicazioni su ciò che è giusto o sbagliato. È una filosofia completa che ha guidato, e continua a guidare, il modo in cui si pensa la società, dall’economia alla politica, dalle relazioni sociali fino alla famiglia.
È una tradizione che risale a più di 2.500 anni fa e che nei secoli è stata continuamente reinterpretata da altri pensatori. Per noi rimane fondamentale, perché ci ha accompagnato in tutte le fasi di trasformazione storica fino alla Cina contemporanea. Per questo la tradizione non è vista come un ostacolo al cambiamento. Al contrario, è uno strumento. È ciò che ci permette di ragionare sul presente e di orientarci nel futuro, con l’idea di continuare a esistere come civiltà anche nei prossimi millenni.
In Occidente, e anche in Italia, la Cina viene spesso rappresentata attraverso narrazioni molto semplificate, come quella sul “credito sociale” – il progetto governativo volto a valutare l’affidabilità di cittadini e imprese attraverso la raccolta di dati, big data e algoritmi, per incentivare comportamenti conformi e “virtuosi” come il pagamento di debiti e a punire quelli indesiderati, influenzando l’accesso a servizi, viaggi e opportunità lavorative – che continua a circolare nonostante molte smentite. Perché, secondo te, queste immagini resistono? Che bisogno soddisfano? E tu come le interpreti, anche a livello personale?
Nel complesso, oggi vedo un miglioramento nel modo in cui i media internazionali parlano della Cina. Però bisogna contestualizzare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi durante la Guerra Fredda si è creato un ordine internazionale in cui inevitabilmente c’era un vincitore. E il vincitore racconta la propria versione della storia, distinguendo tra amici e nemici. Non dico che sia giusto, ma è comprensibile.
In quel contesto, l’immagine della Cina, nel dibattito pubblico occidentale, è nata come quella di un nemico, legata all’idea del “comunismo cattivo”. Questo è stato il punto di partenza, il rumore di fondo che ha accompagnato per decenni il discorso sulla Cina. Narrazioni come quella del credito sociale si inseriscono dentro questa cornice. Confermano un’immagine già esistente: quella di uno Stato totalitario, quasi orwelliano, fondato sul controllo assoluto. È un esempio semplice, immediato, che rafforza una rappresentazione costruita settanta o ottant’anni fa.
Detto questo, oggi vedo segnali di cambiamento. Questa distanza non sta aumentando, ma diminuendo. Sempre più persone cominciano a mettere in discussione certe narrazioni e, anche se resta una posizione minoritaria rispetto ai grandi media, iniziano a circolare analisi più accurate sul tema del credito sociale– ndr] e su altri aspetti della società cinese.
Cambiare una mentalità radicata in Europa o in America richiede tempo. Non si può passare da un’immagine molto negativa a una comprensione più complessa da un giorno all’altro. Però sono contenta di vedere che anche negli Stati Uniti, al di là della retorica politica, si sta lentamente cercando di mostrare la Cina in modo più onesto.
Oggi, nei grandi giornali, la Cina non è più rappresentata soltanto come un Paese “cattivo” che inquina e opprime. Si comincia a riconoscerne la complessità. Questo non significa farne l’elogio o associarla in modo acritico alla sua cultura millenaria, né dipingerla come un modello perfetto. Significa semplicemente provare a comprenderla in modo realistico.
Credo che questo sia un passaggio importante. La conoscenza reciproca richiede tempo.
Anche per noi cinesi non è semplice comprendere la complessità dell’Occidente, che ha grande energia e vitalità, ma anche molte contraddizioni. È un percorso lungo, ma se guardo al punto di partenza, quello della Guerra fredda, sono ottimista. Credo nella conoscenza e nell’intelligenza collettiva dei popoli. Penso che, lentamente, la situazione stia migliorando per tutti.
E se invertiamo la prospettiva? Esistono stereotipi diffusi in Cina sugli occidentali? I cinesi percepiscono differenze tra europei e statunitensi oppure tendono a considerarli simili?
I cinesi sono molto consapevoli della differenza tra europei e americani. Non li percepiscono affatto come la stessa cosa. Da quello che ho sentito spesso, soprattutto nell’ambito degli affari, si ritiene che con gli americani sia più facile collaborare. Sono considerati flessibili, pragmatici, capaci di prendere decisioni rapide. Anche quando ci sono principi da rispettare, vengono visti come più coraggiosi e più spontanei nelle relazioni personali.
Gli europei, invece, appaiono più rigidi, più legati alle regole e alle procedure. Probabilmente questa percezione è influenzata dal fatto che i partner europei più presenti in Cina sono i tedeschi, che investono molto. Di conseguenza, l’immagine dell’Europa tende a riflettere soprattutto quel modello.
In modo molto schematico, gli americani vengono descritti come vivaci e intraprendenti, mentre gli europei come disciplinati, precisi, attenti alle norme. Questo può far sembrare più complesso lavorare con loro. Ma è importante dire che si tratta di stereotipi. Nella realtà le differenze individuali contano molto di più.
Se entriamo nei dettagli, emergono immagini quasi caricaturali. I tedeschi sono spesso considerati seri, “quadrati”, poco inclini all’umorismo. I francesi vengono descritti come un po’ eccentrici, molto romantici, anche se poi nella realtà non è esattamente così. Per quanto riguarda l’Italia l’immaginario è curioso. Nella mente di molti cinesi ci sono due figure simboliche. Una è Andrea Pirlo, il calciatore. L’altra è Silvio Berlusconi, che nonostante le polemiche e i gossip viene comunque visto come un imprenditore di successo, uno che si è fatto da sé, indipendentemente da come ci sia arrivato.
Questo mostra che, in generale, la conoscenza della cultura europea non è ancora molto profonda. C’è ancora molto lavoro da fare anche in questa direzione. Gli inglesi sono probabilmente più conosciuti, perché la Cina ha avuto a lungo rapporti complessi con loro, tra guerre, commercio e la questione di Hong Kong. Ma Paesi come l’Italia, la Spagna, o anche Polonia e Ungheria, sono poco presenti nell’immaginario cinese. Se c’è già confusione tra tedeschi e francesi è facile immaginare quanto sia limitata la conoscenza degli altri Paesi europei.
La comunità cinese in Italia viene spesso descritta come “chiusa”. Secondo te questa definizione ha un fondamento storico e culturale oppure è una semplificazione? C’è un fondo di verità? E come si può spiegare?
Dal punto di vista culturale, una spiegazione esiste. Devo dire che questa cosiddetta “chiusura” ha delle radici. In generale, ai cinesi non piace provocare o creare conflitti. Questo vale soprattutto per quei gruppi che hanno una lunga storia di emigrazione, non solo in Italia ma anche in Francia o in Germania. Chi emigra spesso ha un obiettivo molto chiaro: costruirsi una vita migliore. E per farlo sa che non deve avere problemi.
Non si tratta solo di sopravvivere. Per molti emigrati cinesi l’obiettivo è anche migliorare la propria condizione economica, diventare imprenditori di successo. Sono spesso persone molto ambiziose, che lavorano duramente e non vogliono mettere a rischio ciò che hanno costruito.
Questa apparente chiusura, dal mio punto di vista, nasce soprattutto dal desiderio di proteggere quello che si è ottenuto con fatica. Anche quando subiscono ingiustizie a volte preferiscono non alzare la voce, per evitare conflitti che possano danneggiare il loro lavoro o la loro reputazione. L’idea è: io faccio il mio business, non creo problemi, non mi espongo troppo.
C’è poi un fattore linguistico molto importante. Il cinese è un sistema completamente diverso da quello alfabetico. Molti emigrati della prima generazione hanno un livello di istruzione basso e non hanno familiarità con l’alfabeto latino. Questo rende l’integrazione linguistica molto più difficile. Se non si padroneggia la lingua del Paese in cui si vive è inevitabile che la partecipazione alla vita pubblica sia limitata. Ci si concentra sul lavoro e sulla rete familiare, che diventano uno spazio di sicurezza.
Detto questo, la situazione sta cambiando. Le seconde e terze generazioni sono molto più integrate, parlano perfettamente italiano, frequentano scuole e università, partecipano alla vita sociale. Per loro la chiusura non è più una strategia necessaria. Quindi sì, c’è un fondo di verità nella percezione di una comunità prudente e molto concentrata sul lavoro e sulla stabilità economica, ma ridurla semplicemente a “chiusura” è una semplificazione. Dietro c’è una storia di migrazione, di sacrificio, di adattamento e anche di strategia culturale. Oggi, però, questa immagine non descrive più tutta la realtà.
Se dovessi indicare un’idea o una categoria che un lettore italiano dovrebbe “disimparare” per avvicinarsi davvero alla cultura cinese, quale sarebbe?
Direi di non politicizzare tutto. Quando arrivano notizie dalla Cina spesso vengono lette immediatamente in chiave politica, come se ogni aspetto della società dovesse essere interpretato solo attraverso quella lente. Ma non tutto è politica.
Inviterei a cercare uno sguardo più completo, più umano, più quotidiano. La Cina non è solo un sistema di governo o una strategia geopolitica. È anche una società fatta di persone, famiglie, lavoro, aspirazioni, contraddizioni. Se si prova a osservare la realtà cinese in questo modo, senza partire subito da categorie politiche rigide, diventa più facile distinguere tra propaganda, semplificazioni e ciò che è davvero la vita reale delle persone. Per capire davvero un Paese, bisogna prima imparare a guardarlo come una società, non solo come un attore politico.